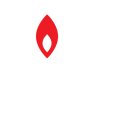Editoriale Jaca Book, 2011
Quasi novanta anni. Tanto c’è voluto perché fosse pubblicato in Italia (da Jaca Book) il fondamentale libro di Sergej Petrovic Mel’gunov Il terrore rosso in Russia 1918-1923. Mel’gunov – scrive Sergio Rapetti in un bel ritratto a lui dedicato che compare nelle prime pagine del libro – discendente di un alto dignitario e governatore ai tempi del regno di Caterina II, collaboratore di Tolstoj (e successivamente curatore della sua opera), socialista, responsabile degli Archivi dopo la rivoluzione di febbraio del 1917, perseguitato dalla Ceka tra il 1918 e il 1922, emigrò a Praga, Berlino (dove nel ’23 diede alle stampe la prima edizione di questo volume) e poi a Parigi, dove si stabilì definitivamente. Fu un convinto e attivo anticomunista; ma durante la Seconda guerra mondiale, a differenza di moltissimi francesi, rifiutò di collaborare con i tedeschi. Morì nel maggio del 1956, avendo avuto la fortuna di conoscere, pochi mesi prima del decesso, il rapporto sui crimini di Stalin che Nikita Krusciov aveva presentato al XX Congresso del Pcus. Il terrore rosso è stato pubblicato, come si è detto, in Germania, ma anche in Francia, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti e un po’ ovunque. Ma non in Italia, nonostante sia da tempo considerato un classico da cui non può prescindere chiunque si occupi dell’argomento.
Il libro è stato scritto alla vigilia della morte di Lenin e spiega, a ridosso degli eventi, come tutte le degenerazioni del sistema sovietico siano riconducibili, appunto, a Lenin. «Gli esponenti bolscevichi», osservava già allora, all’inizio degli anni Venti, Mel’gunov, «sono soliti presentare il terrore come conseguenza della collera delle masse popolari: i bolscevichi sarebbero stati costretti a ricorrere al terrore per le pressioni della classe operaia… il terrore istituzionalizzato si sarebbe limitato a ricondurre a determinate forme giuridiche l’inevitabile ricorso alla giustizia sommaria invocata dal popolo». Niente di più falso: «E difficile immaginarsi un punto di vista più farisaico di questo», proseguiva Mel’gunov, «e si può agevolmente dimostrare, fatti alla mano, quanto tali affermazioni siano lontane dalla realtà». Nell’interessante saggio introduttivo al libro di Mel’gunov, Paolo Sensini accusa senza mezzi termini «la vulgata storiografica compiacente, fraudolenta omertosa e quasi sempre mistificante» che per anni e anni ha impedito di far luce su questi aspetti. Se la prende, Sensini, con la «favola tenacemente radicata in Occidente» secondo la quale – per dar luce alla stagione successiva «splendente» sotto la stella di Lenin – l’epoca zarista viene dipinta come «avvolta dalle tenebre». Menzogna, sostiene Sensini: nella Russia prerivoluzionaria la «società civile esisteva e stava strutturandosi anche grazie a una libertà di stampa che si estendeva ogni giorno di più». A partire dal 1912, Lenin poté far uscire per anni, legalmente e senza che nessuno ne minacciasse la chiusura, il suo giornale «Pravda», sul quale tra il maggio del ’12 e il luglio del ’14 apparvero ben trecento suoi articoli. 11 numero delle famiglie contadine titolari di proprietà passò da due milioni e ottocentomila (pari al 33 per cento dei dodici milioni di famiglie) nel 1905 a sette milioni e trecentomila nel 1915 (pari al 56 per cento delle famiglie che nel frattempo erano cresciute a tredici milioni) con un aumento percentuale del 260 per cento in appena dieci anni. Fu lo stesso Lenin che, dopo la rivoluzione d’Ottobre, trasformò quel mondo in un incubo; Stalin fece il resto.
Nel saggio introduttivo al libro da lui stesso curato, L’età del comunismo sovietico (anch’esso pubblicato da Jaca Book), Pier Paolo Poggio si sofferma sulla circostanza che «le interpretazioni sulla rivoluzione e I’Urss debbono fare i conti con una formidabile costruzione mitologica, senza pari nel corso del Novecento, affermatasi in Occidente e nel mondo, in singolare contrasto con la realtà». L’azione di Lenin e quella di Stalin vengono viste, e giustificate, quali «vettori della modernizzazione e industrializzazione, sia pure a costi spaventosamente alti». Un giudizio che secondo Poggio è da tempo «improponibile» e definitivamente «smentito dall’abbondante storiografia ormai a disposizione». Ma che resiste, osserva ancora Poggio, in virtù della «forza mitopoietica della rivoluzione russa a fronte delle continue smentite che essa ricevette da subito e poi nel corso di tutta la storia dell’Urss». E venuto invece il momento di chiamare le cose con il loro nome: dispotismo, tirannia, sterminio, genocidio, crimini contro l’umanità. Fin dai primi passi della rivoluzione.
Ha scritto Vasilij Grossman che già negli anni di Lenin la violenza aveva cessato «di essere uno strumento per diventare l‘oggetto di un‘adorazione quasi mistica e religiosa». Con il che, secondo Pier Paolo Poggio, l’eterogenesi dei fini è giunta a compimento. Nel Terrore rosso Mel’gunov scriveva che si era in presenza di «un sistema di metodica attuazione della violenza e dell’arbitrio dell‘apoteosi senza remore dell’omicidio inteso come strumento di dominio, alla quale apoteosi non era ancora mai arrivato nessun potere al mondo. Non si tratta di eccessi per i quali si può cercare questa o quella spiegazione nella particolare psicosi indotta dalla guerra civile… L’atrocità morale del terrore, la sua azione disgregante sulla psiche umana, consistono più che nei singoli omicidi in sé, o nel loro numero più o meno consistente, proprio nel suo essere elevato a sistema». E leggendo queste pagine si può dire che tutto era sufficientemente chiaro (ed elaborato) già nel 1923.
(Paolo Mieli, da “Il Corriere della Sera”, 27-07-2010)