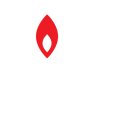traduzione di Duccio Ferri,
Dalai Editore, 2011, pp. 703, euro 19,90
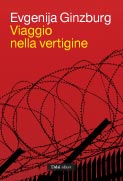
I versi dell’Onegin sul treno per il gulag
Dall’editore Dalai, in integrale, lo sconvolgente «Viaggio nella vertigine» di Evgenija Ginzburg Un documento insostituibile sulle purghe staliniane, che si inserisce nella grande tradizione della letteratura russa
Quando uscì nel 1967 in prima mondiale l’edizione italiana del libro di memorie di Evgenija Ginzburg, Viaggio nella vertigine, l’effetto fu per certi aspetti sconvolgente. All’insaputa dell’autrice, si era riusciti a far pervenire in occidente un documento del samizdat di grandissimo spessore storico, umano e letterario che Marija Olsuf’eva seppe volgere in densa prosa italiana. Scrisse poi l’autrice: «io – che per lunghi anni avevo abitato le tane ghiacciate dei deportati … avevo la fortuna di essere pubblicata in una città che rispondeva al suono melodioso di Milano». E oggi giunge a noi finalmente anche la redazione completa dell’opera, oggetto di sofferti rifacimenti e integrazioni protrattisi fin proprio agli ultimi giorni di vita dell’autrice, scomparsa nel 1977 (Dalai Editore, traduzione di Duccio Ferri, pp. 703, euro 19,90).
Madre dello scrittore Vasilij Aksenov, autore del celebre Biglietto stellato, la Ginzburg è personalità complessa, di autentico talento letterario e di profonda sensibilità umana, e il libro oggi sugli scaffali delle librerie italiane nella sua interezza si presenta come un documento insostituibile per chi voglia avvicinarsi alla tragedia delle purghe staliniane e del Gulag e, nel contempo, come un capolavoro letterario, nel quale le terribili esperienze biografiche e psicologiche dell’autrice in tutta la loro cruda autenticità e immediatezza sono nel contempo presentate con maestria letteraria e in una ardita tessitura di reminiscenze.
Oltre che nel suo valore di documento, la grandezza di questo libro sta proprio in questa sua dimensione che si inserisce nella migliore tradizione della grande letteratura russa. E d’altra parte la Ginzburg, entusiastica attivista del movimento operaio, membro del partito a Kazan’, collaboratrice del giornale «Krasnaja Tatarija», era donna di fine formazione culturale che seppe vivere e sopportare le tragiche prove della sua vita nel conforto e nel sostegno morale della poesia, tanto da attribuire alla propria esperienza un significato anche artistico.
Celebre è la scena della lettura a memoria di gran parte dell’Evgenij Onegin che la Ginzburg sostiene in un affollato carro merci del treno che la sta portando alla Kolyma per dimostrare ai carcerieri della scorta e al loro capo Solovej che nessuna delle detenute cela con sé un libro (cosa vietata dal regolamento) e nel contempo che nessuno può imprigionare il pensiero, la memoria, l’arte. Episodio che ci ricorda una celebre lirica di Mandel’stam dedicata al fiume Kama. Nelle tre parti dell’opera la Ginzburg distribuisce l’esperienza dell’arresto (per aver conosciuto lo storico Nikolaj El’vov accusato di trotzkismo) e della prigione (dall’isolamento della detenzione nel corso dell’inchiesta, tra Kazan’ e Mosca, dalla «torre di Pugacev» alle angustie del carcere di Jaroslavl’, dove «guardare apertamente il cielo era proibito»), poi dopo la caduta del «nano-mostro» Ezhov, il trasferimento attraverso i lager di transito, gli anni della prigionia siberiana, nella Kolyma, a Magadan e poi nella tajga, l’estremo nord a El’gen (il toponimo in jakuto significa «morto»). Seguono gli anni successivi alla liberazione, ma sempre in stato di esilio a Magadan, dove la Ginzburg ritrova la compagna di cella Julia, il ricongiungimento con il figlio Vasilij (l’altro figlio perì nella Leningrado assediata), un improvviso nuovo, terribile arresto nel 1949, tra altre peripezie e incontri fino alla riabilitazione. Vengono poi anni appesantiti dal fardello della memoria e l’ansia per una rilettura critica dell’intera esperienza dello stalinismo.
Appartenendo all’élite del partito, la Ginzburg porta dati e giudizi importanti per la ricostruzione della storia del Pcus e del destino di molti dei suoi dirigenti di spicco e riflette la psicologia di chi credeva ciecamente nel partito, fino a dubitare, almeno nei primi tempi, che Stalin sapesse cosa davvero succedeva nel paese. Frequenti sono i paralleli con la Germania nazista anche attraverso le testimonianze delle prigioniere tedesche del Komintern, che avevano conosciuto le celle della Gestapo. Allo stesso tempo, gli incontri, le intense amicizie di prigionia e lager, il contatto con una misera umanità degradata oltre alla soglia della sopravvivenza tra slanci eroici e azioni ignominiose, permettono all’autrice di offrire un quadro d’insieme, un affresco sociale, psicologico e spirituale, che acquista ora toni epici, ora lirici, ora di fredda osservazione naturalistica. A colpire il lettore è la lunga schiera di personaggi, vittime e aguzzini (spesso come nel caso del maggiore El’sin presentati in entrambi i ruoli), la cui vita è come sospesa tra il ricordo di ciò che pare irrimediabilmente perduto e un futuro segnato da sconforto e abbandono o irreale e crudele incredulità.
Oggi, proprio come per la Shoah, sembra quasi assurdo che tutto ciò sia potuto avvenire. Ed egualmente banale è l’incarnazione del male nell’inesorabile funzionamento burocratico della macchina repressiva, come nella scritta sugli incartamenti dei condannati: «conservare in eterno». Ecco così tracciati con essenzialità pittorica e precisione psicologica le compagne di cella, dalle vecchie social-rivoluzionarie, che avevano conosciuto le galere zariste, a Ljama, giovane rimpatriata dalla comunità di émigré in Cina, alla giovanissima Nina Lugovskaja (le sue memorie furono edite anni addietro anche in italiano), dai cinici e violenti inquisitori, tra cui lo spietato Vevers, ai tanti secondini, sorveglianti e guardie della scorta, dai medici e infermieri dei lager (splendido il ritratto di Anton Walter, il medico tedesco cui la Ginzburg si legherà affettivamente), ai tanti criminali comuni, dai dirigenti in semilibertà delle varie pesantissime forme di lavoro coatto ai rappresentanti delle numerose nazionalità del crogiuolo sovietico. E infine il rattristito mondo animale e la severa natura siberiana.
Nell’originale il testo è una fonte ricchissima per la ricostruzione degli aspetti linguistici del mondo carcerario e concentrazionario sovietico (evidente anche in alcuni dei titoli attribuiti ai capitoli che riportano tutta la specificità gergale del mondo carcerario) e, lo voglio sottolineare, il traduttore con lodevole sforzo (e qualche inesattezza) spiega nelle numerose note anche molti dei termini e dei realia relativi alla vita della prigione sovietica. Egli rileva inoltre, nei limiti del necessario, le citazioni e i rimandi, anche se, ovviamente, molto rimane nascosto. La profonda struttura intertestuale del testo necessiterebbe di ben altri approfondimenti: riporto, a mo’ d’esempio, il passo «le pesanti catene si spezzeranno, le galere crolleranno», citazione di una celebre lirica di Puskin dedicata ai decabristi, e il riferimento al «bey algerino» che è un evidente rimando alle Memorie di un pazzo di Gogol’.
Questo è comunque un libro di tale ricchezza culturale e di tale spessore umano che malgrado la mole non concede al lettore un attimo di rilassamento e distacco. La scrittura è coinvolgente, senza cadute o prolissità, e rende il lettore intensamente partecipe degli stati d’animo e delle esperienze degli eroi delle tante vicende e storie del lager. Nota quasi con stupore la Ginzburg: «Sì, proprio qui in prigionia ho incontrato il sentimento del congioire, molto più raro e difficile del compatire…». La lettura del Viaggio nella vertigine provoca proprio questa sensazione di gioia stupita e primigenia: la gioia che questo messaggio sia giunto a noi in tutta la sua pienezza e vitalità!
(Stefano Garzonio, “Il Manifesto”, 1 maggio 2011)