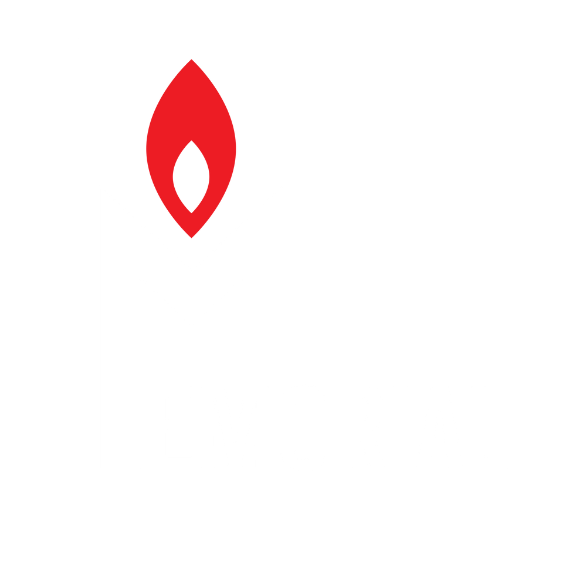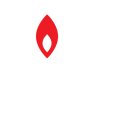Václav Havel, scomparso il 18 dicembre scorso, è ricordato come il primo presidente della Cecoslovacchia non comunista, artefice della caduta del Muro, l’uomo di Charta 77 e della rivoluzione di velluto. Fu qualcosa di più, e di diverso. Nato a Praga il 5 ottobre 1936 in ambiente intellettuale, cominciò a scrivere e comporre giovanissimo. La sua prima opera è del 1959 (Tutta la vita davanti), seguita da Metamorfosi, nel 1961. In breve si affermò come drammaturgo e poeta ed entrò a far parte dell’Unione degli Scrittori. Scioccato dall’esito della Primavera di Praga, definì la restaurazione portata dai carri armati come “il regime dell’oblio”. E quando Jan Palach, Jan Zajic e Ezven Plocek si diedero fuoco per protestare contro la passività del proprio popolo, Havel affermò che la società aveva compreso. Ognuno capiva la necessità di fare qualcosa di estremo: Palach e gli altri lo avevano fatto per tutti. Ci si rese conto allora, che quel socialismo illiberale e post-totalitario era davvero il socialismo, e che tutte le altre possibili alternative, pur in quello stesso ambito ideale, fossero definitivamente decadute.
Václav Havel, scomparso il 18 dicembre scorso, è ricordato come il primo presidente della Cecoslovacchia non comunista, artefice della caduta del Muro, l’uomo di Charta 77 e della rivoluzione di velluto. Fu qualcosa di più, e di diverso. Nato a Praga il 5 ottobre 1936 in ambiente intellettuale, cominciò a scrivere e comporre giovanissimo. La sua prima opera è del 1959 (Tutta la vita davanti), seguita da Metamorfosi, nel 1961. In breve si affermò come drammaturgo e poeta ed entrò a far parte dell’Unione degli Scrittori. Scioccato dall’esito della Primavera di Praga, definì la restaurazione portata dai carri armati come “il regime dell’oblio”. E quando Jan Palach, Jan Zajic e Ezven Plocek si diedero fuoco per protestare contro la passività del proprio popolo, Havel affermò che la società aveva compreso. Ognuno capiva la necessità di fare qualcosa di estremo: Palach e gli altri lo avevano fatto per tutti. Ci si rese conto allora, che quel socialismo illiberale e post-totalitario era davvero il socialismo, e che tutte le altre possibili alternative, pur in quello stesso ambito ideale, fossero definitivamente decadute.
Nell’aprile del 1975, dopo aver fondato le edizioni «Expedice», Havel scrisse una famosa lettera aperta all’allora capo del partito comunista, Gustáv Husák, nella quale parlava della crisi morale e spirituale che stava vivendo la società; denunciava l’auto alienazione, la dissimulazione e la fuga nel privato.
Secondo Havel, gli uomini della reazione avevano capito la minaccia che pendeva sopra l’esistenza del regime il quale, per conservarsi, doveva privarsi di ogni spinta rinnovatrice. Da quel momento, e per venti anni, fino alla rivoluzione di velluto del 1989, tutti i meccanismi della manipolazione, diretta e indiretta, della vita si svilupparono creando un sistema che Havel chiamò “totalitarismo maturo e avanzato”. La rivoluzione e il terrore lasciarono il posto all’immobilità, all’omologazione, all’anonima burocrazia stereotipata. Dalla caduta di Dubček fino alla rivoluzione di velluto si sarebbe formato all’interno della società cecoslovacca un dualismo che comprendeva la verità ufficiale e quella ufficiosa e condivisa, che escludeva la prima. Il grado di tolleranza del sistema si misurò nella forza dell’opinione informale di imporsi come generale. Il nascente dissenso e la nascita di Charta ‘77, cercarono di costringere il regime al rispetto delle sue stesse leggi. Dopo gli accordi di Helsinki, infatti, il partito comunista fu costretto a misurare l’uso della repressione contro gli oppositori.
L’epoca grigia di rassegnata apatia, però, continuò: mentre piccoli centri focali di resistenza venivano scoperti e repressi, la comunità faceva finta di non. Il regime ottenne come risultato più visibile del suo operato la fuga della gente comune dalla realtà quotidiana, dai problemi sociali e dalla politica. Alcuni argomenti diventarono proibiti e la storia fu sostituita da una pseudostoria celebrativa. Havel ricorda i primi anni Settanta come l’epoca della sospensione della storia. Era come se il divenire avesse perso la sua cadenza naturale, la direzione e il mistero, per trasformarsi in automanifestazione e autocelebrazione unilaterale di un unico soggetto, centro di verità e di potere. Dato che il tempo umano può essere esperito solo attraverso gli avvenimenti, iniziò a scomparire l’esperienza stessa del tempo, che cominciò a girare in tondo. Gli accadimenti si alternavano attraverso un prima e un dopo assolutamente simili, tanto che diventava difficile distinguere un anno dall’altro, mentre una serie di celebrazioni scandivano l’anno, dal Primo maggio alla Liberazione, dall’8 Marzo all’Insurrezione nazionale slovacca, dalla Festa dell’esercito al Febbraio vittorioso.
Assumendo la riflessione di Edmund Husserl sulla realtà del mondo immanente come il solo luogo in grado di misurare la morale, Havel tornò sul concetto della Lebenswelt come del mondo nel quale tutti viviamo, luogo che nutre la condizione di vivere nella verità. La parte secondaria di tutti i fenomeni e le entità distinte nel mondo che noi possiamo osservare, annunciare o esperire esistenzialmente in vari modi, è qualche cosa che possiamo definire come un «ordine generale dell’Essere». Tale Essere è compartecipe di tutte e in tutte le culture le quali, pur essendosi diversificate migliaia di anni fa, assumono ancora nel presente i medesimi archetipi di base, che non sono mai stati abiurati. La storia intera del cosmo, e specialmente della vita, è registrata quindi nel lavorio interno di tutti gli esseri umani e dopo migliaia di anni persone di epoche diverse e di culture lontane sono unite come parti dello stesso Essere; tutte le culture presumono l’esistenza di qualche cosa che Havel chiama «Memoria di Essere», nella quale viene continuamente registrato ogni aspetto della vita; le garanzie della libertà umana e della responsabilità personale si ritrovano non già nei programmi politici o nei sistemi di pensiero, bensì nella relazione tra l’uomo e il trascendente, di cui egli è parte integrante.
Partendo da queste riflessioni, Havel individuò nella Primavera di Praga l’ultimo atto, la proiezione esteriore di un dramma condotto nell’ambito dello spirito e della coscienza della società. La primavera di Praga come l’esito ultimo della società socialista, non come un suo risveglio, che sarebbe avvenuto solo venti anni dopo, con la fine del comunismo e la sua, involontaria ma necessaria, salita al Castello.
Marco Clementi