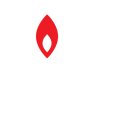Interviste agli ultimi testimoni, a cura di Memorial.
ABDUL-WAHIT DADAEV RICORDA: LA DEPORTAZIONE
Abdul-Wahit Dadaev è nato nel 1936 nel villaggio di Samaški, nella RSSA Ceceno-Inguscia.
Il 23 febbraio del 1944 è stato deportato con la sua famiglia in Kazakistan. Nel 1960 è tornato a
Samaški con la moglie e i figli. Durante la prima guerra cecena del 1995, la casa di Abdul-Wahit e
quelle di due suoi figli sono state distrutte. Da rifugiati hanno vissuto in Inguscezia e nell’Ossezia
del Nord. Adesso vivono con dei parenti.
IL CONVOGLIO
Avevamo una casa di tre stanze, al pianterreno. Ecco, mio padre si chiamava Zubair e mia
madre Amanta. Il fratello più grande Abdul-Halim. Io, il secondo, Abdul-Wahit, il terzo Said-
Hasan, la sorella Kajpa.
Lavoravano. Coltivavano patate, mais, seminavano il grano. C’erano cavalli e bufali. Si
viveva bene prima della deportazione.
Girava voce che i ceceni non volessero combattere, l’hanno riferito a Josif Vissarionyc
Stalin e lui ci ha fatto deportare tutti, i cabardino-balcari, i caraco-circassi, i ceceno-ingusci, per il
fatto che non prestavamo servizio, non combattevamo. Così ho sentito dire dagli anziani. Io ero un
ragazzino, allora.
Nel ’44 ci hanno deportato in Kazakistan, regione di Taldy-Kurganskij, zona di Alakul’skij,
villaggio di Majskoe. Lì abbiamo vissuto 13 anni.
A.K. Ricorda cosa accadde quel giorno?
A.D. Quel giorno, ecco… con le mitragliatrici puntate, prima hanno preso gli uomini, i
padri, li hanno messi sui carri bestiame. Poi hanno messo sul carro le donne e i bambini. Abbiamo
viaggiato per 18 giorni sui carri bestiame, fino in Kazakistan. Ecco, ricordo che gridavano
attraverso il finestrino. Su un binario c’era il nostro convoglio e su quello accanto il secondo
convoglio. Attraverso il finestrino gridavano: “Da dove?” – “Noi da Acchoj-Martan, Samaški”, da
tutta quella zona. E gridavano, da Gudermes, Argunov, era il loro vagone. Me li ricordo.
A.K.. Cosa vi hanno dato da mangiare sul convoglio, nei 18 giorni di viaggio?
A.D. 18 giorni e 18 notti. Carne di cammello, dicevano, zuppa, queste cose. Un centinaio di
grammi, ma di carne non ce n’era. Anche zuppa di riso, d’avena, di miglio. Di pane ne davano circa
200 grammi.
A mia madre non hanno fatto prendere nulla. Noi.. eravamo sei fratelli. Il fratellino minore
per mano, poi io, più grande, e il fratello maggiore, di 14 anni. Io ne avevo 8. E anche Kajpa, la
sorella, era piccola. Quindi, non era riuscita a prendere nulla. C’era dolore ovunque. Con i bambini
non sapeva che fare. Abbandonarli non si poteva.
Neanche il cibo aveva portato, non glielo avevano lasciato prendere. Sotto il tiro delle
mitragliatrici, i cani pastore, ecco, sono stati cacciati via tutti: “Chiudete a chiave e consegnate le
chiavi”. Anche le chiavi hanno requisito.
A.K. Viaggiavate tutti sullo stesso vagone, donne, bambini e uomini?
A.D. Sì, sì, sì.
A.K. E di giorno il convoglio si fermava?
A.D. Si fermava di giorno e di notte. Per le nostre necessità, ecco, avevamo vergogna. La
vescica scoppiava, una ragazzina di 15 anni e anche una donna anziana sono morte. C’era un
bugliolo lì, ma si vergognavano e così morivano. Un neonato succhiava il seno anche dopo che la
donna era morta. Mi ricordo tutto del vagone. Ecco, i cadaveri… non si riusciva ad ogni stazione,
appena qualcuno moriva, a.. scaricarli. Alla stazione ammassavano i cadaveri e se uno di loro aveva
figli o una moglie, una figlia, allora piangeva, voleva scendere a seppellire il padre, o la madre.
Loro questo… non lo permettevano, non aprivano le porte ed era vietato scendere. E così, buttavano
il cadavere nell’acqua e lo coprivano con la neve, dio solo sa come. Era così. Una pena atroce.
LA VITA IN KAZAKISTAN
In seguito ci hanno smistato negli alloggi; lì ci vivevano i kazaki e raramente i russi.
“Questa famiglia la prendo io”, dicevano i kazaki. “Questa famiglia la prendo io”, così dicevano. Ci
hanno preso con sé.
Per esempio, un padrone di casa ha accolto noi, in un’altra casa ne prendevano altri e così in
un kolchoz vivevano centoventi, centocinquanta ceceni. C’erano buoi, aravano con i buoi,
coltivavano frumento, mais, patate.
…ci hanno aiutato, con una tazza, un boccale, fiammiferi, legna; in genere loro… erano
musulmani e anche noi siamo musulmani. I kazaki ci hanno aiutati.
Dicevano che avevamo lo stesso sangue, la stessa fede, che il Corano è uno. Solo la lingua
era diversa, ma avevano compassione, ci aiutavano.
C’era guerra, fame e freddo dappertutto. Non era il clima del Caucaso. Faceva freddo là, in
Kazakistan. Molti ceceno-ingusci sono morti di fame, di freddo. Non abbiamo trovato nulla di
buono in Kazakistan. Perché anche loro, i kazaki, avevano fame. C’era la guerra.
Là, uno più grande di me di due anni, si chiamava Tahir, è morto di fame. La gente, là,
anche i kazaki, si nutrivano di erba, bietolone, di tutto… i nomi non li conosco, però mangiavano
l’erba, la pancia si gonfiava e morivano, soprattutto i bambini e le persone anziane.
C’era la fame. Non abbiamo trovato nulla di buono in Kazakistan.
Non si poteva lasciare la regione. Ogni mese bisognava registrarsi, firmare. Il comandante
del distretto arrivava e i padri e le madri venivano registrati. Non si poteva uscire dalla regione.
C’erano le guardie.
Là ho imparato il kazako, la scuola russa non c’era. Ho fatto 9 anni di lingua kazaka. Ho
lavorato come autista e prima come trattorista. Là mi sono sposato e ho compiuto 20 anni. Quando
ho compiuto 20 anni mi sono sposato. Adesso ho cinque figli e tre figlie.
A.K. Quali norme di vita avete osservato in Kazakistan?
B.B. Cecene
A.K. Cecene
A.D. Rispettare gli anziani, innanzitutto. Ecco, se uno sta portando qualcosa, un paio di
secchi… o magari un’anziana, allora il giovane deve dare una mano, portare i secchi a casa sua o
dove bisogna portarli. E bisogna lasciar passare gli anziani, ecco. Ne abbiamo molte, per tradizione.
Rispetto per gli anziani, per un’anziana, aiutarsi a vicenda. Se si sta costruendo una casa, o
ridipingendo, tutti danno una mano.
IL RITORNO
Più tardi ci hanno permesso di tornare in patria. Nikita Sergeevic
Chrušcëv ha ordinato di far
tornare tutti i ceceno-ingusci in patria e di ricostituire la repubblica autonoma Ceceno-Inguscia. Nel
’56 -’57 tutti i ceceni e gli ingusci sono partiti dal Kazakistan diretti verso il proprio paese.
A.K. Cosa ne avete fatto di quello che avete lasciato nel Kolchoz di Taldy-Kurgan, la vostra
casa o magari qualche altra cosa?
A.D. Là… è tutto più economico. Così l’abbiamo dato via per poco. Vivevamo lì
temporaneamente, non per sempre. Erano alloggi, strutture provvisorie. Là… vivevamo come
potevamo. Non le compra nessuno, quindi le abbiamo lasciate. Ci viva chi vuole.
A.K. Nella sua famiglia, da suo padre, c’è qualcosa, un oggetto qualunque, che le sia rimasto
della vostra vita prima della deportazione?
A.D. Il Corano.
A.K. … da suo padre?
A.D. Sì, il Corano.
A.K. Quindi, quando siete stati deportati suo padre ha portato con sé il Corano?
A.D. Già
A.K. E conserva quel libro in casa sua?
A.D. Sì
B.B. Nient’altro?
A.D. Nient’altro.
A.K. Mi dica, il 23 febbraio, che è sempre stata la festa delle Forze Armate Sovietiche…
A.D. Sì?
A.K. Com’era percepita in casa sua quella giornata?
A.D. Da noi, come dire? [Si emoziona] Era come un giorno da funerale, una giornata nera.
In ogni casa c’erano lacrime, ricordi. [Pausa.] È meglio che non mi chieda, non ci riesco. Non
voglio nemmeno ricordare. È terribile. È stato terribile.
A.K. Lei ha sempre voluto tornare, non ha mai pensato di rimanere in Kazakistan?
A.D. Sì, noi, adesso saremmo felici se fossimo rimasti in Kakzakistan fino ad oggi.
A.K. Perché?
A.D. Perché in Kazakistan si può fare fortuna e [Tossisce] dopo due guerre, nel ’96, nel
novanta… nel ’95, ’96, fino al 2000 molti ceceni sono morti e molte case sono state distrutte. È
duro vivere nel Caucaso.
In generale, non ho visto nulla di buono. Nervosismo, preoccupazione, ecco. A cosa serve la
guerra, a chi serve la guerra? Per esempio, io ho cinque figli e tre figlie. Non mi dispiace per loro?
Certo che sì. Puškin ha scritto: “Al sole si sta caldi, con la mamma si sta bene, non c’è miglior
amica della mamma”. Anche i miei figli guardano con amarezza al padre, alla madre. A loro
dispiace… [Tossisce]. Si preoccupano anche per il padre, per la madre.
Adesso, dopo due guerre, il desiderio è di… costruire una casa… vivere… con la famiglia,
né più né meno, ecco, in pace, senza guerra, vivere insieme alla famiglia.
Testi:
Alena Kozlova, Irina Ostrovskaja (Memorial – Mosca)
Traduzione italiana di Zeno Gambini