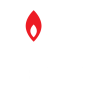Nella foto: Il presidente dell’Azerbaigian
Ilham Aliyev
(foto di President.az, CC BY 4.0, Link)
(di Simone Zoppellaro)
28 agosto 2025
alle 13:59
La guerra tra Azerbaijan e Armenia, che si trascina da oltre trent’anni ai confini dell’Europa con decine di migliaia di morti, pulizie etniche da entrambe le parti, interi paesi e città rasi al suolo, sembrerebbe aver trovato una conclusione. Dati i tempi in cui viviamo, forse una tragedia di tale portata non poteva che finire con una farsa. E così è stato. La conferenza stampa dell’accordo di pace firmato a Washington l’8 agosto scorso ha visto il presidente azero Ilham Aliyev, con l’approvazione del primo ministro armeno Nikol Pashinyan, proporre una candidatura per il Premio Nobel per la Pace a Donald Trump, seduto accanto a lui e visibilmente compiaciuto.

(foto ufficiale della Casa Bianca di Daniel Torok).
“Un miracolo,” come lo ha definito Aliyev, quello compito in pochi mesi per arrivare all’accordo dal presidente americano. Che ha contraccambiato lodando il lungo periodo di potere ininterrotto che il suo collega, con il pugno di ferro, ha saputo mantenere a Baku: “Ventidue anni: niente male. Significa che è intelligente e tenace,” ha detto Trump, che, poco prima, sempre di fronte alle telecamere, discuteva con Aliyev l’eventualità di una sua terza candidatura.
Show mediatico a parte – e pur con tutta la condivisibile cautela espressa da diversi analisti – si tratta di un passo importante di un percorso avviato dalla diplomazia dei due stati del Caucaso meridionale già prima dell’arrivo al potere di Trump. In diciassette punti assai sintetici pubblicati pochi giorni dopo la firma, l’accordo vede il riconoscimento reciproco dei confini tra i due paesi sulla base di quelli che separavano, prima della dissoluzione dell’Urss, le repubbliche socialiste sovietiche di Armenia e Azerbaijan. Le parti si impegnano, inoltre, a “non avanzare alcuna rivendicazione […per la modifica dei confini] in futuro”. E ancora: i due stati, leggiamo, “non intraprenderanno alcun atto, compresa la pianificazione, la preparazione, l’incitamento e il sostegno di azioni che mirino a smembrare o a pregiudicare, del tutto o parzialmente, l’integrità territoriale o l’unità politica dell’altra parte”.
Non è un punto scontato: caduta la questione dell’autodeterminazione per gli armeni del Karabakh, dopo la disfatta militare armena del 2020 e l’ulteriore offensiva di Baku del 2023, restava aperta la questione delle crescenti rivendicazioni della propaganda azera circa un non meglio determinato “Azerbaijan occidentale,” ovvero i territori stessi dell’attuale Repubblica di Armenia. Inoltre, per quanto il documento pubblicato non tocchi esplicitamente il tema, i due governi hanno annunciato il raggiungimento di un accordo su quello che, negli ultimi anni, sembrava essere l’ostacolo maggiore per poter arrivare a una pace: la richiesta di Baku di un corridoio infrastrutturale tra l’Azerbaijan e la sua exclave del Nakhichivan che transiti in territorio armeno nei pressi del confine con l’Iran.
Battezzato ufficialmente come TRIPP, acronimo che sta per Trump Route for International Peace and Prosperity, questo offrirebbe per novantanove anni i diritti esclusivi di sviluppo e gestione a un consorzio statunitense, nell’auspicio di coniugare i profitti economici derivanti dalla costruzione di infrastrutture e dallo sfruttamento commerciale in un’ottica di sostenibilità economica e politica. In attesa di capirne di più, e sperando non si tratti solo – si perdoni il gioco di parole – di un bad trip, la prospettiva ha sollevato dubbi e proteste in Iran e in Russia, che temono di veder ridotta la loro influenza nella regione. Infine, come ha scritto lo stesso Trump sulla sua piattaforma Truth Social, “gli Stati Uniti firmeranno accordi bilaterali con entrambi i Paesi per perseguire insieme opportunità economiche, in modo da saper sfruttare appieno il potenziale della regione del Caucaso meridionale.”
Coniugando, alle solite, cinismo, narcisismo e un approccio brutalmente pragmatico che cerca in primis un immediato tornaconto tanto mediatico quanto economico, Trump porta a casa un risultato concreto che, nelle sue intenzioni, vorrebbe mettere in ombra il fallimento della sua diplomazia per quanto riguarda l’Ucraina. Nonostante le sue evidenti difficoltà ad azzeccare persino lo spelling di Azerbaijan e Armenia, l’accordo potrebbe rappresentare un ritorno in primo piano degli Stati Uniti nella regione. Se la Russia era stata protagonista indiscussa nella mediazione tanto del cessate il fuoco del 1994, che aveva posto fine alla prima guerra del Karabakh, sia di quello del 2020, che aveva determinato la sospensione dei combattimenti della seconda, fra l’altro dispiegando l’esercito russo in Karabakh in presunta funzione di peacekeeping, il fatto che l’accordo di pace sia stato firmato a Washington alla presenza di un presidente statunitense ha un impatto simbolico che non andrà sottovalutato, al di là alle prospettive economiche e politiche di cui si diceva. Non che gli USA fossero in precedenza assenti dallo scenario: a loro spettava, insieme a Russia e Francia, la copresidenza del gruppo di Minsk, struttura creata nel 1992 dall’OSCE, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, per la mediazione del conflitto in Karabakh. Ma il salto di qualità è tangibile, e – con la sola eccezione dei due paesi coinvolti, ovvero Azerbaijan e Armenia – rischia di rappresentare uno smacco per gli altri attori in precedenza impegnati nella mediazione.
“È una terribile umiliazione per la Russia,” ha dichiarato il propagandista di regime Aleksandr Dugin su Telegram, poi ripreso da Deutsche Welle. “È una sconfitta totale, un disastro completo per la nostra politica nel Caucaso meridionale”. Toni drammatici a parte, e con il dovere di ricordare come, al contrario, l’influenza russa si sia assai rafforzata negli ultimissimi anni nel terzo paese della regione, la Georgia, il protagonismo trumpiano rappresenta un ulteriore passo indietro per una Russia sempre più impopolare in Armenia, proprio mentre assistiamo a una parziale rottura del regime di Aliyev con Mosca, dovuta anche al crescente ruolo di fornitore di energia di Baku per l’Unione Europea e alla sua ascesa diplomatica internazionale. Appaiono lontanissimi i tempi in cui analisti improvvisati – in Italia ciò era pressoché la regola – volevano ridurre, sbagliando, la guerra in Karabakh a un conflitto per procura tra Ankara e Mosca.
A perdere, senza dubbio, è anche l’Iran, i cui tentativi di espandere la sua influenza nella regione in passato avevano prodotto tensioni sia, in modo sensibile ma non troppo eclatante, con Mosca che, più apertamente, con Baku. E, a differenza della Russia, in questo caso più dimessa, Teheran si è affidata in questi giorni a una protesta più accesa. Con i toni un po’ truculenti tipici di chi non ha molte carte da giocare, Ali Akbar Velayati, ex ministro degli esteri della Repubblica Islamica tra 1981 e 1997 ed ora consigliere per le relazioni internazionali della guida suprema Ali Khamenei, ha dichiarato: “Questo corridoio non diventerà una porta d’accesso per i mercenari di Trump, ma il loro cimitero.” Per l’Iran, il fatto di avere un nuovo dispiegamento statunitense nei pressi dei suoi confini è uno smacco che va ad aggiungersi al recente netto indebolimento della sua posizione in tutto il Medio Oriente.
Non meno sensibile è il tracollo e, insieme, l’inanità dimostrata dalla diplomazia europea, la cui influenza nella regione va riducendosi ulteriormente. Il fallimento del Gruppo di Minsk, che a giorni dovrebbe cessare di esistere dopo trentatré anni di attività, è il coronamento di decenni di esitazioni, ipocrisie e fallimenti e, per quanto la notizia in questo periodo balneare non abbia raggiunto molti, rappresenta un segno epocale, paragonabile, su piccola scala, all’incapacità dimostrata dalle nostre diplomazie durante le guerre nella ex-Jugoslavia negli anni Novanta. In un conflitto ultratrentennale fra due paesi situati ai nostri confini, che sono parte del Consiglio d’Europa fin dal 2001 e che hanno rapporti vitali con le nostre economie (basti pensare al ruolo del gas e del petrolio azero in Italia), la voce dell’Europa è semplicemente irrilevante, assente, a tratti apertamente sbeffeggiata. Dopo il successo del Ministero del Made in Italy, sarebbe forse il caso ribattezzare i nostri affari esteri (non solo a Roma, ma in tutta Europa) con la denominazione più appropriata di Ministeri del Wishful Thinking.
Più complessa la lettura per quanto riguarda i paesi coinvolti. Per Yerevan e Baku, per diverse ragioni, l’accordo rappresenta un passo positivo verso una stabilizzazione interna, ma anche verso un consolidamento di potere che rischia di avere conseguenza negative in senso autoritario, soprattutto per l’Azerbaijan, dove la famiglia Aliyev è ai vertici del potere quasi ininterrottamente fin dal 1969. Non è per nulla una buona notizia, invece, per la sempre più esile e perseguitata opposizione azera, ormai sotto attacco quotidiano e con sempre meno supporto da parte della cosiddetta comunità internazionale. Discorso analogo si può fare per gli oltre centomila armeni del Karabakh, espulsi dalle loro case, in quella che il Parlamento Europeo, fra gli altri, non ha esitato a definire una pulizia etnica. È “come se non esistessimo,” ha scritto di recente in un articolo la giornalista Siranush Sargsyan.
Se Pashinyan ha discusso con Trump la questione dei prigionieri armeni nelle carceri dell’Azerbaijan, nulla di concreto è stato però intrapreso per loro, come per gli attivisti, ricercatori e giornalisti azeri che condividono la loro sorte, di cui non si è affatto parlato. Ma ciò è parte di questo terribile gioco, e la pace in salsa trumpiana ignora in modo sistematico le vittime e la società civile in toto, guardando esclusivamente a affari e potere.
Il conflitto, nato per il controllo del Nagorno-Karabakh, territorio da secoli a maggioranza armena attribuito da Mosca all’inizio degli anni Venti del secolo scorso all’Azerbaijan sovietico, era esploso negli anni Ottanta, quando la perestrojka aveva fatto riemergere rivendicazioni, tensioni e violenze che avevano già insanguinato in passato la regione. Dopo l’indipendenza di Armenia e Azerbaijan, la prima guerra, conclusa dal cessate il fuoco del 1994, aveva determinato la vittoria di Yerevan e la creazione di una Repubblica del Nagorno-Karabakh che, non riconosciuta da alcun paese al mondo, paradossalmente neppure da Yerevan, era proseguita fino al suo scioglimento, avvenuto il primo gennaio 2024. Un esito, questo, che è stato diretta conseguenza della seconda guerra del Karabakh, avvenuta nel 2020 e che, rovesciando gli esiti militari di quella precedente, aveva portato Baku a una riconquista della totalità dei territori perduti in precedenza, decretando al contempo l’espulsione dell’intera popolazione autoctona armena.
L’attuale corrispondenza fra confini etnici e di stato dei due paesi, in netta controtendenza rispetto alla storia di un territorio estremamente composito da un punto di vista linguistico e religioso (“la montagna delle lingue”, così gli arabi chiamavano il Caucaso nel Medioevo) rappresenta purtroppo una sconfitta – l’ennesima – di un’Europa incapace di andare oltre le sue prediche e la sua falsa coscienza”.
Si tratta di una pace vera o solo di un pessimo spettacolo, che avrà la durata effimera uno spot? Presto per dirlo. Se gli esperti si dividono, in questi tempi insidiosi e convulsi la prudenza è quantomai d’obbligo. Ma una cosa è certa, però, e non rappresenta affatto una buona notizia. Se pace sarà, non sarà per tutti. Oppositori, minoranze, attivisti per i diritti umani e giornalisti che non si piegano alla propaganda di regime: per loro, salvo un cambiamento di rotta radicale che al momento sembra poco probabile, la pace è nel Caucaso del Sud più che mai lontana.