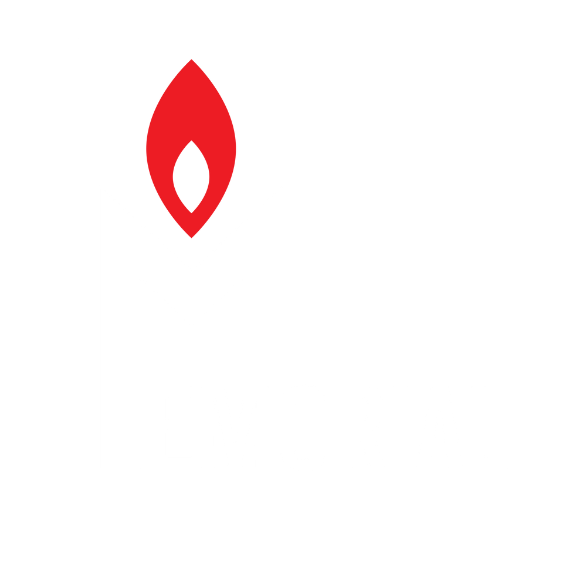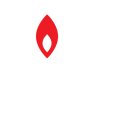La mappa dei negazionismi di Stato
Dallo sterminio degli armeni alla Shoah, dal colonialismo alla questione irlandese Chi vuole falsificare il passato oggi può contare su nuove, potenti strategie comunicative
di Marcello Flores
Corriere della Sera 26.2.12
Negazione, revisione, rimozione: attorno a questi termini si svolgono da anni, in tutto il mondo, history wars, guerre di interpretazione su eventi drammatici e luttuosi, che non riguardano solo gli storici ma, spesso, governi e Stati, popoli e minoranze, vittime e carnefici. All’interno della memoria pubblica la questione del negazionismo ha acquistato, con gli anni, sempre più spazio. La conoscenza storica è stata spesso manipolata, travisata, riabilitando o condannando per interessi politici, ideologici, statali.
Di negazionismo in senso stretto, ossia di storici che negano realtà assodate e riconosciute da tutti, vi è forse solo il caso della Shoah, venuto alla ribalta negli anni Settanta e poi amplificato negli anni Novanta a opera di un ristretto manipolo di storici (o autoproclamatisi tali). I campi di sterminio e l’uccisione di cinque-sei milioni di ebrei avrebbero costituito, per costoro, una «menzogna», il risultato di un complotto giudaico. Pochi e squalificati (i più noti sono Robert Faurisson e David Irving), i negazionisti hanno costruito nuove strategie comunicative e approfittato del sorgere di movimenti neonazisti per ottenere attenzione dai media, rimanendo sempre del tutto marginali e ininfluenti, ma contribuendo alla rinascita di rigurgiti di antisemitismo. Con l’appoggio al negazionismo del presidente iraniano Ahmadinejad si è ulteriormente diffusa, soprattutto nel mondo arabo, una visione riduttiva e minimizzatrice della Shoah, vista come mito fondatore dello Stato di Israele più che come evento cruciale del Novecento.
Di negazionismo di Stato si è parlato molto anche a proposito del genocidio degli armeni. Il famigerato articolo 301 del codice penale turco — che ha permesso di portare in tribunale per «offese alla turchità» centinaia di persone, tra cui il Premio Nobel Pamuk, ree di ricordare il massacro degli armeni — rappresentava la minaccia più pesante che lo Stato turco poneva su chi volesse parlare di genocidio. Il negazionismo turco si è basato per anni sull’attività di istituzioni accademiche e di storici occidentali compiacenti che hanno ridimensionato o attribuito alla violenza di guerra, o a quella preventiva contro il possibile tradimento degli armeni, i massacri iniziati nel 1915 (tra essi Stanford Shaw e Justin McCarthy con una posizione più giustificazionista, ma anche Bernard Lewis con l’intento di minimizzare). Oggi la strategia è quella di chiedere che vengano poste «sullo stesso piano» interpretazioni diverse, senza insistere sulla negazione in sé, con l’obiettivo di far diventare legittime, pur se discutibili, le interpretazioni che riducono a poche centinaia di migliaia le morti armene (di fronte alle stime ormai consolidate tra 1 e 1,5 milioni di morti), poste a confronto con quelle superiori sofferte dai turchi nel corso della Prima guerra mondiale. Di qui la dura protesta del governo di Ankara contro la legge francese che punisce chi nega le stragi degli armeni.
Gran parte del dibattito rimane ancorato alla possibilità di usare il termine genocidio — dizione fortemente avversata dallo Stato turco — in una querelle terminologica che ha riguardato anche altri casi. Tra questi quello della carestia in Ucraina nel 1932-33, che causò la morte di almeno 5 milioni di persone (altre stime parlano di 7 e il governo ucraino di 10) in seguito a direttive politiche del regime staliniano per piegare l’opposizione contadina alla collettivizzazione e la ripresa di movimenti nazionalistici. La rivendicazione dell’Holodomor («uccisione per fame») come genocidio o crimine contro l’umanità è ormai largamente accettata, ma vi sono ancora forti resistenze a riconoscerlo — e ad ammetterne la matrice politica — soprattutto in Russia.
Il dibattito sulle vittime del comunismo può ormai poggiarsi su solide basi documentarie. Negato negli anni 50 e 60 da molti simpatizzanti, compresi storici e intellettuali, accettato ma minimizzato negli anni 70 quando Solženicyn ne portò alla ribalta la tragica esperienza, dibattuto sulla base della documentazione disponibile negli anni di Gorbaciov, il sistema del Gulag è oggi unanimemente riconosciuto nella sua estensione, profondità e tragicità. Tra il 1930 e il 1952 vennero condannate alla fucilazione 1 milione di persone, 19 milioni a pene detentive in campi e prigioni, 30 ai lavori forzati e ad altre misure repressive.
È sul versante statale che si sono avute forme preoccupanti di rimozione che hanno alimentato disinteresse e disinformazione da parte dell’opinione pubblica russa sul suo passato. Putin ha sottolineato la grandezza di Stalin, espresso rammarico per la scomparsa dell’Urss, celebrato i «monumentali risultati» del periodo sovietico, festeggiato i servizi segreti e reintrodotto l’inno nazionale dell’Urss; Medvedev ha istituito nel 2009 una commissione per contrastare «la falsificazione della storia a danno della Russia», ma non, evidentemente, quella a suo vantaggio. I numerosi libri dello storico Jurij Zhukov, (l’ultimo del 2011 dal titolo inequivocabile Essere orgogliosi e non pentiti. La verità sull’epoca staliniana) stanno conoscendo diffusione e successo. Come molti libri divulgativi che relativizzano i crimini del comunismo e rivalutano l’epoca staliniana soprattutto per il periodo di guerra, grazie all’influenza della chiesa ortodossa.
Shoah, genocidio armeno, Gulag, non sono gli unici eventi su cui si sono cimentati il revisionismo storiografico o la rimozione pubblica. In Francia la discussione ha ruotato attorno al regime di Vichy e al colonialismo in Algeria, e ormai solo qualche sparuto storico militare è ancora disposto a negare i risultati della ricerca su entrambe le questioni. Cosa che fanno alcuni politici e giornalisti per influenzare l’opinione pubblica in una rivalutazione esplicita della grandeur francese e nella riproposizione di tabù sul collaborazionismo o l’uso della tortura nelle colonie. Una legge del 2005 sottolineava il «ruolo positivo del colonialismo» e la creazione da parte di Sarkozy di un ministero insieme dell’Immigrazione e dell’Identità nazionale ha rilanciato la discussione sulla «frattura coloniale», spingendo a posizioni (come quella di Daniel Lefeuvre in Farla finita col pentimento coloniale) che tendono a negare o ridimensionare non più i fatti ma le interpretazioni e le attribuzioni di responsabilità.
Il dibattito in Cile, Argentina e Uruguay si è svolto anch’esso più attorno alle interpretazioni e definizioni, ai ridimensionamenti e ai silenzi sugli eventi legati al passato dittatoriale di quei Paesi, che non su vere e proprie negazioni. In Argentina si rifiuta il carattere genocidiario della repressione giovanile (sancito da alcuni tribunali nazionali), in Uruguay si sottolinea il ruolo della violenza dei gruppi dell’ultrasinistra nel favorire la reazione militare, in Cile si valorizzano le misure economiche dell’epoca di Pinochet: è su questi terreni che le guerre della memoria sono passate anche in ambito accademico, non più limitate al dibattito pubblico sulle amnistie, le responsabilità, i risarcimenti.
In Gran Bretagna il dibattito sulla «questione irlandese» continua a essere acceso, sia sulla carestia del 1845-52 (un milione di morti, due milioni di emigrati negli Usa, altrettanti ospitati nelle terribili workhouse dell’epoca: una tragedia «naturale» fortemente aggravata dalla mancanza di misure adeguate e da scelte errate compiute dal governo britannico) sia su innumerevoli episodi della lotta indipendentista negli anni Venti. Ma è sul periodo più recente che la battaglia è più acuta: il rapporto Saville del 2010 ha smentito il rapporto Widgery del 1972 sulle responsabilità del Bloody Sunday a Londonderry, attribuendole alle Forze armate britanniche e non più alle associazioni irlandesi. Ma la recente decisione di obbligare il Boston College a consegnare agli inglesi le interviste ai militanti dell’Ira (una ricchissima documentazione storica) come prove per una possibile incriminazione, si presenta come una pesante intromissione della politica nel lavoro degli storici.