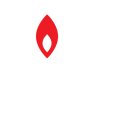Deportato in Siberia a due anni, sul Mar Glaciale Artico
Deportato in Siberia a due anni, sul Mar Glaciale Artico
di Alessandro Vitale dell’Università degli Studi di Milano.
«Avevo due anni quando quelli della polizia segreta bussarono col calcio dei fucili alla nostra porta e ci portarono via. In quei giorni, fra il 15 e il 18 giugno 1941, dalla Lituania insieme con noi, mio padre e mia madre – entrambi insegnanti poco più che trentenni – e la mia sorellina di un anno, deportarono in Siberia su carri bestiame quasi diciottomila persone. Il quaranta per cento erano bambini di meno di sedici anni. C’erano numerose donne incinte e la metà di loro morì durante il viaggio, che durava settimane».
Nel suo appartamento della splendida città di Kaunas – capitale della Lituania fra le due guerre – il Professore di matematica in pensione dell’Istituto Tecnologico, Romualdas Markauskas, al quale mi ha condotto l’amica Professoressa Maryte Ereminiene (incontrare i superstiti dei campi è delicato e risveglia terribili ricordi) e dal quale mi reco con il Professor Claudio Barna, già Professore d’Italiano nell’Università “Vytautas Il Grande”, mi racconta in lituano – antichissima e musicale lingua indoeuropea, la lingua vivente più prossima al sanscrito – la sua incredibile infanzia di deportazione, prima nei monti Altai, in Siberia e poi in uno dei luoghi più terrificanti dell’Arcipelago GULag, fra i più inospitali del pianeta insieme alla Kolyma: Trofimovsk, un’isola sul delta e alle foci dell’immenso fiume Lena, nel Mar di Laptev, Oceano Artico, ottocento chilometri a nord del circolo polare, all’estremo nord siberiano. In quel luogo, che in Lituania risuona sinistramente come ovunque Auschwitz, costantemente omesso dalle cartine del GULag – forse perché troppo difficile da credere – furono deportati cinquecento Lituani, numerosi Finlandesi, Yakuti ed Ebrei. È poco noto, ma anche questi ultimi, a migliaia – come ha dimostrato lo storico Alfonsas Eidintas – furono deportati in massa dai sovietici dalla Lituania in Siberia, in quel giugno infernale. L’Olocausto nazista non era ancora incominciato. I Lituani erano quasi tutti donne, anziani, bambini inermi: la maggioranza non riuscirà più a tornare a casa. Nell’inverno 1942-’43 metà dei Finlandesi (in massima parte della regione di Lenigrado, che non parlavano nemmeno in finlandese) e un terzo dei Lituani morirono a Trofimovsk di malattia (scorbuto, tifo, dissenteria), freddo, denutrizione, sfinimento per lavoro pesante.
Conoscendo già quella tragedia inenarrabile, pensavo di incontrare un anziano stanco, restio a raccontare. Invece Romualdas è una persona giovanile, simpatica, di grande semplicità e con senso dell’umorismo. La sua voce è serena e distesa, sebbene a tratti tradisca un dolore sconfinato e mai sopito per tutti quelli che in quelle condizioni disumane non ce la fecero, a differenza sua e dei suoi genitori e fratelli, che tornarono in Lituania nel 1957, dopo otto anni di disperata sopravvivenza nell’isola di Tit Arai, a due passi da Trofimovsk e dopo dieci anni a Yakutsk, altra gelida città siberiana. A differenza di tanti altri, poi, dalla sua famiglia non fu separato il padre, come invece accadeva regolarmente già alla stazione di partenza. Il capofamiglia, infatti, era volutamente inviato in campi o prigioni di altre città siberiane (soprattutto Krasnoyarsk), dove quasi senza eccezioni trovava la morte. La vicenda dei Lituani deportati al Mar di Laptev è ora più nota in Italia, grazie alla traduzione del 2009 (rifiutata da più editori, per vecchi e infondati pregiudizi) delle memorie di Dalia Grinkevičiute, I Lituani al Mar di Laptev (Lietuviai prie Laptevų jūros), ritrovate da una vicina dopo la scomparsa dell’Autrice, che le aveva sepolte in giardino e soprattutto dopo la traduzione dello splendido libro di Ruta Šepetys, lituano-americana di seconda generazione, Avevano spento anche la luna (Garzanti), best-seller pubblicato in inglese in America, che ha commosso tutto il mondo, in gran parte ispirato al racconto di Dalia. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Barlassina (Monza) l’hanno rappresentato con intense repliche fra gennaio e febbraio del 2015, nell’atto unico di Giuseppe Terranova, in occasione di un Giorno della Memoria originale e particolarmente sentito. La famiglia di Romualdas conobbe quella della Grinkevičiute nei luoghi di deportazione e ne condivise gli stenti. Come dal racconto di Dalia, sgorgano dalle sue parole i ricordi di spaventose condizioni di vita e di morte: un trauma che continua a segnare generazioni di Lituani che hanno avuto parenti deportati nei luoghi più remoti della Siberia. «Ho vissuto la mia infanzia come in un incubo di nebbie, su un altro pianeta. Ma sono tornato. Per miracolo. Eravamo sepolti vivi, condannati a scomparire nel vento, nel ghiaccio eterno. L’inverno artico durava dieci mesi l’anno. Si arrivava a 50 gradi sottozero. La Lena era ghiacciata per sette mesi all’anno. Il vento era sempre forte. Le tempeste di neve uccidevano in continuazione. La notte artica durava un tempo infinito, intere stagioni. Si tiravano corde per non perdersi anche a poca distanza dalle baracche, che i deportati dovettero costruire con le loro mani: case fatiscenti che avevano le pareti interne sempre ricoperte di ghiaccio. Ci davano pochi grammi di pane al giorno. Dovevamo trascinare tronchi pesanti, nei mesi estivi con le gambe nell’acqua gelida e d’inverno con il pericolo di morire nella neve. Molti si addormentavano sul lavoro per il gelo e finivano assiderati. I compagni di deportazione non avevano nemmeno la forza per trascinarli via. Il pesce, l’unico alimento che ci poteva salvare dallo scorbuto e dall’avitaminosi, era molto raro, perché lo inviavano al fronte o lo lasciavano marcire deliberatamente, piuttosto che darlo a persone destinate a morire. I morti congelati erano accatastati fino a formare colline e rimanevano insepolti, esposti alle bianche volpi artiche, che li sfiguravano. Pochi s’illudevano di rivedere la loro Patria. Ma il ricordo di vent’anni d’Indipendenza (1918-1940) – nei quali la Lituania era rinata – spingeva a resistere anche in quelle terre senza speranza. Mio fratello Jonas nacque a Trofimovsk nel 1946». Anche la sopravvivenza finiva per essere una protesta individuale e collettiva in questo “campo artico della morte”, fra i più estremi di tutti i tempi. «Eppure, fra congelamenti, punizioni corporali, incarceramenti, trovammo anche persone umane. Ci salvammo anche grazie a loro». Al rientro in Lituania però – un Paese devastato e ormai in condizioni molto differenti rispetto al periodo interbellico – li aspettavano difficoltà continue: quella di trovare un lavoro, un alloggio e i continui controlli del KGB «…Che osservava tutto. Però non avevamo più paura di niente. Eravamo già stati all’inferno». Il racconto di quanti legami i deportati abbiano conservato con i pochi Yakuti e con gli Ebrei, oggi ormai in Israele, scampati alla morte bianca di Trofimovsk, è del pari commuovente. «Gli Ebrei che erano con noi a Trofimovsk (molti di loro non riuscirono a tornare e già ne erano morti tanti nel viaggio di migliaia di chilometri lungo la Lena) ci hanno invitato in Israele. Gli Yakuti sono venuti a trovarci con i loro splendidi costumi colorati – dice Romualdas mostrandomi le foto – e hanno partecipato alle nostre commemorazioni. Siamo come fratelli. Nel 1989 siamo tornati con una spedizione a Tit Arai e a Trofimovsk. Le rive delle isole sono state erose dal mare. Molti corpi sono scomparsi, trascinati nell’Oceano artico. Ma nella sabbia abbiamo trovato ancora qualcuno dei nostri morti, preservati dal gelo». Il Professore mi mostra una serie di sue fotografie digitali in bianco e nero di quella spedizione, con gli scavi di qualche tomba. Da quei volti consunti, da quegli stracci che ancora avvolgono le persone scomparse allora, sembra d’improvviso emergere tutta intera una storia di sofferenza senza fine. Nonostante il sorriso mite e buono di Romualdas e la sua squisita ospitalità, esco dalla sua casa in preda a un’angoscia profonda. Ma il viaggio nella memoria del Novecento vissuto dai Lituani non è finito.
La tappa successiva è con Kotryna Vilkaite, dai nonni Aušra e Henrikas. La nonna Aušra nel giugno del ‘41, a cinque anni, fu deportata negli Urali con due fratellini minori, il padre e la madre Kotryna Žemaityte-Juškiene, sorella del generale Jonas Žemaitis, leggendario capo militare e partigiano che guidò la durissima e disperata lotta, di un intero popolo, contro l’occupazione sovietica dal 1944 (dopo aver per anni cercato di contrastare i Tedeschi occupanti e le loro vessazioni, particolarmente dure per i Lituani) – motivato anche dalla deportazione della sorella. Jonas Žemaitis fu assassinato nel 1954, dopo la cattura, a Mosca, nei sotterranei della Lubianka, il tristemente noto quartier generale della polizia segreta. Nel 1949 era stato proclamato Presidente della Lituania fino alla Liberazione e a elezioni libere. Aušra riuscì a fuggire dal luogo di deportazione e a tornare in Lituania, su treni lenti, con la fame e la paura dei controlli. In Lituania in quel periodo la lotta partigiana e le repressioni erano al loro culmine. Fu arrestata come una criminale, incarcerata fra interrogatori e giorni di terrore (con una pratica illegale anche per la legge sovietica di allora, nei confronti di minorenni), sospettata di avere contatti con lo zio Jonas Žemaitis e rispedita ai piedi degli Urali, incarcerata in una prigione dopo l’altra (Raseiniai, Leningrado, Vologda), sotto continui interrogatori insieme con la cugina Laima, anche lei minorenne, condannata al campo di lavoro. Anche Laima è qui oggi con noi. I suoi occhi, durante i racconti che ascolta in silenzio, sembrano spaziare su terre sconfinate, fra ricordi di esperienze per noi inimmaginabili. Laima aveva quattordici anni. Aušra ne aveva tredici e conobbe Henrikas nella deportazione, dove rimase per altri vent’anni. Ricorda ancora il lungo buio dell’inverno al nord, l’estenuante lavoro nei boschi, i chilometri quotidiani di cammino, il freddo, la mancanza di diritti dei deportati, le continue umiliazioni e vessazioni, le difficoltà per curare le malattie, la mancanza d’indumenti adeguati e soprattutto la fame, che spingeva a cercare di scappare. Henrikas Vilkas fu deportato nel 1941, a tredici anni, con le sorelle e la madre a Syktyvkar, antico luogo di deportazione zarista (vi vennero confinati anche i soldati prigionieri della Grande Armée di Napoleone, nel 1812), capoluogo di una regione costellata nel Novecento di miniere e di campi di lavoro. Il padre, ex vice maggiore, fu eliminato nel campo di concentramento di Reshoty nel 1943, separato dalla famiglia come tanti altri padri lituani. La madre morì nella deportazione, nel 1942. Anche Henrikas riuscì a scappare con la sorella nel 1947 e a tornare illegalmente in Lituania, dove nel 1949 fu arrestato e rimandato nelle terre del Nord, nel lager di Ust Vym, ai piedi degli Urali, dove fu imprigionato per tre anni prima di essere reinviato a Syktyvkar, nella regione dei Komi. Aušra e Henrikas tornarono in Lituania nel 1970 con le loro figlie Elena e Marija. Fino alla metà degli anni Ottanta la vita in Lituania sotto il regime sovietico per gli ex deportati era molto dura. Era difficile trovare lavoro, studiare, vedersi assegnato un appartamento. Non si poteva raccontare quello che si era vissuto. Tuttavia ce la fecero, seppur con grande, ulteriore fatica.
I nonni di Kotryna Vilkaite (oggi sposata in Italia, che ha partecipato alla Misja Sibiras, un progetto lituano che prevede spedizioni in Siberia di giovani selezionati per preparazione ed energia, per restaurare i cimiteri dei deportati e raccogliere testimonianze dei sopravvissuti) raccontano le loro infanzie spezzate. Ciò che colpisce è la loro profonda serenità: quella di chi ha vissuto qualcosa di incredibile. Sono l’immagine del coraggio e della dignità di un intero popolo. Un popolo perseguitato e decimato da una “guerra contro i bambini”. Un popolo “tornato all’Europa” da pochi anni, che non conosciamo ancora.
[nggallery id=81]