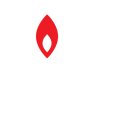Cattiva memoria. Perché è difficile fare i conti con la storia di Marcello Flores
Cattiva memoria. Perché è difficile fare i conti con la storia di Marcello Flores
Il mulino
PECCATI DI MEMORIA
TROPPI STORICI ACCETTANO DI OPERARE COME «ESPERTI AL SERVIZIO DI UNA CAUSA»
Paolo Mieli su Corriere della Sera 7 giugno 2020
Marcello Flores critica in un saggio (il Mulino) il modo in cui si costruiscono identità collettive attraverso l’uso politico del passato. Il tema delle gravi atrocità compiute dai regimi comunisti e ancora adesso alquanto sottovalutate
Troppa enfasi sulla memoria, troppo poca storia. Questi sono stati, negli ultimi decenni, i difetti del nostro modo di guardare al passato. In particolare un eccesso di riguardo nei confronti della cosiddetta «memoria collettiva». Gli storici avrebbero dovuto far argine in qualche modo al dilagare della memoria. Ma non ne sono stati capaci. È l’opinione di Marcello Flores, argomentata in un libro, Cattiva memoria. Perché è difficile fare i conti con la storia, che esce giovedì 11 giugno per il Mulino.
Come è potuto accadere? Per i condizionamenti subiti dalla politica. È abbastanza scontato — sostiene Flores — che l’establishment di un Paese cerchi di costruirne l’identità «utilizzando in proprio — attraverso cerimonie, anniversari, celebrazioni, musei, statue, mausolei, opere letterarie e artistiche, insegnamento della storia nelle scuole — scelte politiche e iniziative pubbliche che riescano a coinvolgere intellettuali ed esperti specializzati». Attenzione, però: «Se la memoria collettiva di una nazione — ma anche di una comunità, di un gruppo etnico o religioso, di un partito — è una ricostruzione del passato in funzione del presente, il ruolo dello storico che si identifica con quella nazione, quella comunità, quel partito, non può essere che quello dell’esperto al servizio di una causa». Non è più uno studioso che si autoimpone un tasso rigoroso di scientificità, diventa l’«esperto al servizio di una causa». Ciò non comporta, prosegue Flores, che «inevitabilmente» le verità storiche vengano adattate alla necessità dell’ideologia. Certo è, però, che quegli «esperti al servizio di una causa» vengono spinti fortemente «a determinare certezze oltreché giudizi coerenti e utili all’identità condivisa». Tutto ciò che non è funzionale a rinforzare le suddette certezze, nonché i «giudizi coerenti e utili all’identità condivisa», verrà abbandonato, per così dire, ai bordi della strada maestra.
Lo storico del Novecento (ma in parte anche quelli del secolo precedente) «ha partecipato attivamente alla manipolazione ideologica e alla strumentalizzazione propagandistica della propria produzione». Quantomeno «ha permesso che ciò accadesse». Sempre più ha voluto presentarsi «come costruttore volenteroso di un’identità collettiva, di una memoria comunitaria cui offriva la legittimazione della propria disciplina e del proprio ruolo accademico». Una costruzione dell’identità che «è insieme un processo politico e culturale». Con «una prevalente direzione dall’alto verso il basso, dal potere verso la società».
Era stata la modernità dell’illuminismo «a ricacciare indietro la memoria e a far crescere la domanda di storia». Il primato della ragione, concede Flores, non cancellava certo né le emozioni né le esperienze individuali. Ma «tendeva a leggerle sotto una visione nuova dominata dalla forza dell’intelletto». A partire da allora, pur in forme diverse e con proposte a volte contraddittorie e contrastate, la storiografia ha conosciuto uno sviluppo crescente, «diventando un elemento cruciale nella formazione dell’identità collettiva delle nazioni e dei popoli». Lo aveva già notato il famoso autore francese Ernest Renan in un celebre discorso del 1882 pubblicato con il titolo Che cosa è una nazione? (Donzelli).
In un altro libro che, secondo Flores, «non è stato accolto con l’attenzione che avrebbe meritato» — Elogio dell’oblio. I paradossi della memoria storica (Luiss University Press) — il saggista americano David Rieff ha sostenuto che la memoria collettiva assomiglia, più che alla storia, «a un misto di mito e propaganda» e che la convinzione che rappresenti un «dovere morale» calcola male quanto essa possa essere «fomentatrice e sobillatrice di rabbia, conflitti, violenze». Impossibile che nessuno si sia accorto di quel che ha notato Valentina Pisanty in I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe (Bompiani). E cioè che negli ultimi vent’anni in cui la Shoah «è stata oggetto di capillari attività commemorative in tutto il mondo occidentale», proprio negli anni dal 2000 al 2020 «il razzismo e l’intolleranza sono aumentati a dismisura soprattutto nei Paesi in cui le politiche della memoria sono state implementate con maggior vigore».
Anche la storia del comunismo è finita stritolata «tra rimozione e demonizzazione». Soprattutto rimozione, tant’è che gli ex comunisti sono tra i principali beneficiari di questo privilegio accordato alla memoria. Flores ricorda la risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 «sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’europa» che ebbe in Italia un’eco «molto più accesa e polemica che in qualsiasi altro Paese». Emanuele Macaluso, ex dirigente del Pci, la definì «vergognosa» in quanto avrebbe messo sullo stesso piano nazismo e comunismo. Strano, osserva Flores, dal momento che non c’era «una sola parola, neppure un lontano riferimento» che potesse far pensare che quel documento intendesse «equiparare nazismo e comunismo». Si diceva soltanto che il patto Molotov-ribbentrop (agosto 1939) aveva «spianato la strada allo scoppio della Seconda guerra mondiale», ciò che è oggi accettato da quasi tutti gli storici.
Ancor più colpito fu Flores da un appello pubblicato dal «manifesto» il 24 settembre 2019, nel quale si sosteneva che mentre il nazismo nel produrre i suoi orrori non aveva fatto altro che «realizzare i propri programmi», «i regimi comunisti, prima e dopo la guerra, allorquando si macchiarono di gravi e inaccettabili violazioni della democrazia e delle libertà, tradirono gli ideali, i valori e le promesse fatte». La vera colpa del comunismo storico, chiosa Flores, in sostanza non sarebbe stata quella di macchiarsi di «gravi e inaccettabili violazioni della democrazia» («un modo certamente eufemistico», puntualizza lo studioso, «per parlare dei milioni di vittime nel Gulag, delle deportazioni di minoranze etniche, della soppressione fisica delle opposizioni, di processi farsa che costrinsero gli imputati a dichiararsi colpevoli di nefandezze mai compiute»), ma quella «di non aver realizzato le promesse fatte». I firmatari di quell’appello, tutti nomi assai prestigiosi, prosegue Flores, «non si sarebbero mai permessi, in una loro opera, di ridurre la storia dei regimi comunisti» a quel commento «ridicolo e
offensivo (per le vittime oltre che per la verità storica)».
Il fatto è che, pur se «la conoscenza storica del comunismo è ormai ampiamente assodata e approfondita», questo «sembra aver avuto un’incidenza solo limitata nel trasformare la memoria pubblica che del comunismo si ha». In generale «rimangono dei riflessi condizionati che spingono a utilizzare alcuni cliché che vengono ripetuti senza interrogarsi sui loro significati». Che senso ha, si domanda Flores, ricordare — quando si parla delle vittime del Gulag o degli altri crimini commessi dal comunismo — i venti milioni di morti sovietici durante la Seconda guerra mondiale? Molti di loro tra l’altro — e per Flores andrebbe ricordato anche questo — furono uccisi anche per colpa dell’incompetenza e delle «scelte strategiche di Stalin»…
E inoltre: perché assai spesso «quando si evidenzia la ovvia e riconosciuta — per fortuna da parte ormai di tutti — mancanza di libertà e di democrazia, oltre che di una continua logica repressiva intrinseca ai regimi comunisti, si sente il bisogno di sottolineare la maggiore uguaglianza (sociale, culturale) che avrebbe caratterizzato le società comuniste rispetto
Contraddizioni
È difficile giustificare la «doppiezza» che portava il comunismo italiano a lottare per la democrazia e a difendere l’esperienza dell’urss
a quelle democratiche e capitaliste?» Perché tra i «successi» dell’urss in epoca staliniana si continua spesso a ricordare l’industrializzazione accelerata dei primi piani quinquennali, dimenticando che ne era parte integrante anche la catastrofe sociale che l’accompagnò e che avrebbe pesato a lungo sui destini del Paese?».
Flores è stato altresì colpito da un altro commento alla risoluzione del Parlamento europeo, in cui il Gulag veniva paragonato alle vittime dell’industrializzazione capitalistica dell’inghilterra e dell’europa nell’ottocento, considerando quest’ultima un «crimine ben maggiore e condannabile» assai più dell’universo concentrazionario sovietico, «come se i due eventi fossero commensurabili» ed entrambi fossero «il risultato di scelte politiche e ideologiche». Quando la memoria prende il sopravvento, scrive, e dimentica il ruolo di «comprensione» della storia, «è facile cadere nella logica del giudizio, del tribunale, della condanna, favorendo analogie che creano solo confusione nella conoscenza e rimandano a più generali e astratte questioni morali». La minimizzazione o relativizzazione dei
crimini del comunismo fatta ancora oggi «nasce, in realtà, dalla volontà di testimoniare la propria opposizione al mondo capitalista, alle sue profonde ingiustizie e terribili esperienze per masse di persone, cercando per questo di “salvare”, almeno in parte, l’unica esperienza storica che si è concretizzata come un’alternativa radicale e totale al capitalismo».
Si può comprendere che i reduci del Pci e i loro «compagni di strada» non possano «fare a meno di difendere — moralmente e psicologicamente — il proprio passato e l’impegno per una società più giusta, vissuto e profuso sotto le insegne del movimento comunista». Ma resta difficile, sul piano storico, giustificare la «doppiezza» che portava il comunismo italiano a lottare convintamente per la democrazia e a difendere l’esperienza dell’unione Sovietica, in modo totale e acritico fino agli anni Sessanta e poi, con qualche piccola distanza e distinguo, fino agli anni Ottanta». Nelle generazioni più giovani, d’altra parte, l’ossessione per la battaglia contro il «neoliberismo», un termine che è diventato il «punto di riferimento per indicare il disprezzo per qualsiasi posizione o figura politica che la sinistra consideri allontanarsi dal vero “socialismo”», ha teso «a indebolire i risultati della ricerca storica sul comunismo e a far affiorare sempre più frequentemente brandelli di memoria tesi a esaltare la generosità e l’eroismo della lotta anticapitalista lasciando in ombra le strutture totalitarie e le politiche repressive del comunismo». La battaglia sulla memoria del comunismo, conclude, si svolge in sostanza sul terreno della morale assai più che su quello della storia.
Invece è alla storia che dovremmo tornare. È la dimensione storica complessiva, secondo Flores, che dovrebbe alimentare nuovamente la possibilità di uno sguardo comune europeo sul passato. Ma lo stesso, sottolinea, «può e deve valere nell’ambito di singoli Stati e nazioni». Questa dimensione storica complessiva serve a ricollocare le memorie parziali nel contesto globale e a «porre fine al contrasto storia/memoria che può servire solo a chi intende strumentalizzare entrambe in un’ottica di manipolazione della verità o di narrazione utile a fini propagandistici e identitari (cioè per contrapporsi ad altrui identità)».
Aleida Assmann, in Sette modi di dimenticare (il Mulino), sostiene che «la memoria è sempre limitata, perché si riferisce alla prospettiva dell’esperienza di un individuo o di un gruppo». Per collocare qualcosa nella memoria, aggiunge, «occorrono sforzi particolari» e sono sforzi «che pagano» dal momento che la memoria «fonda comunità». Si esercita il ricordo, secondo Assmann, «per appartenere alla comunità e perché nella memoria del gruppo si vorrebbe anche sopravvivere». Dopodiché va detto anche che «senza il dimenticare le cose non funzionerebbero». E qui Flores si richiama a una celebre frase dello scrittore francese Honoré de Balzac: «I ricordi rendono la vita più bella, dimenticare la rende più sopportabile». E si giunge alla rivalutazione dell’oblio come medicamento per gli eccessi della memoria.