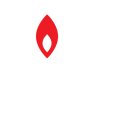Dagmar Šimková, Io, n° 1211.
Dagmar Šimková, Io, n° 1211.
Paoline, Milano 2014
pagg. 197
€ 17
Trad. e cura di Tiziana Menotti
Introd. di Alessandro Vitale.
Fin dai tempi delle “Mie prigioni” di Silvio Pellico la memorialistica carceraria ha attirato l’interesse dei lettori, sia di quelli semplicemente interessati agli aspetti più crudi o morbosi delle varie esperienze, sia di quelli attenti a cogliere il minimo particolare, per arrivare ad una generale condanna del regime che aveva incarcerato il – o la malcapitata. Il libro di Dagmar Šimková, Io n°1211 (titolo originale Byly jsme tam taky, letteralmente “C’eravamo anche noi”, dal quale, nel 2011, il regista Vojtěch Bárta ha ricavato una pièce teatrale), edito recentemente dalle edizioni Paoline nell’eccellente traduzione di Tiziana Menotti e con un’esauriente e precisa Introduzione di Alessandro Vitale, alla quale si uniscono rilevanti presentazioni di storici, registi e scrittori cechi, si distacca da altre testimonianze del genere non solo perché per la prima volta è stato tradotto in italiano un testo che fa riferimento alle carceri cecoslovacche degli anni più bui del regime, vale a dire nei primi anni Cinquanta, quando il regime di Gottwald si caratterizzava per una repressione spietata di qualunque forma di dissenso – superando in durezza e ferocia altri regimi dello stesso colore politico nell’est Europa – ma anche per la singolarità dell’esperienza dell’allora giovane ragazza praghese. Dagmar, nata nel 1929, proveniente da una ricca famiglia di Písek, città della Boemia meridionale e cresciuta nel vivace ambiente della Facoltà di Lettere dell’Università Carlo di Praga, viene sorpresa, come altri suoi compatrioti, dal colpo di stato del febbraio 1948 (poi definito dal regime “Febbraio Vittorioso”), che portò al potere il partito comunista e il suo leader Clement Gottwald, un convinto fanatico stalinista. Per la sua provenienza sociale, ma soprattutto per essere una fervente cattolica, in uno Stato (ancor oggi) poco religioso, la ragazza deve interrompere gli studi, sbarrati per tutti coloro che non erano di “estrazione proletaria”, diventando infermiera nella città dei suoi genitori. La sua vita tuttavia viene soprattutto stravolta dall’arresto, avvenuto nel 1952, a soli 23 anni, con l’accusa di “tradimento e spionaggio”, che poteva comportare anche la pena di morte. Come nota Alessandro Vitale, una pratica questa tipica dello Stato moderno (del quale il totalitarismo del Novecento è stato il massimo vertice di coerenza), che non si differenzia in questo in nulla da una cosca mafiosa. Dagmar viene condannata a quindici anni di reclusione. Il libro ripercorre, con dovizia di particolari, di immagini molto forti e con un linguaggio particolarmente crudo e realistico, la tragica esperienza in quelle carceri disumane, con prigionieri alle prese con altrettanto inumani carcerieri, spesso posti volutamente e appositamente alle sue costole. Nelle carceri dei regimi totalitari i cosiddetti “politici” erano (e lo sono ancora) sempre trattati con spietata durezza (come si può notare anche nei testi di Solženicyn o in quello di Dario Fertilio, Musica per lupi – dedicato all’analoga , terribile esperienza di alcuni carcerati dello stesso periodo in Romania) e l’esperienza di Dagmar non fa eccezione. Quello che risalta particolarmente dalla lettura del testo è la speranza, la grande fede in Dio e in fondo negli uomini, l’estrema compostezza delle reazioni dell’Autrice, anche di fronte alle efferatezze alle quali viene sottoposta. La sua testimonianza serve al lettore odierno, sia egli credente o non credente, come “prova vivente” della volontà pianificata dei regimi totalitari di annientare il dissidente, di annichilire la sua volontà e personalità, di portarlo agli estremi della sottomissione, per poterlo poi “forgiare”, “cambiare” (secondo il tipico progetto demenziale e il corrispondente concetto di “uomo nuovo”), conducendolo a un’obbedienza cieca e assoluta verso il regime. Il diario di Dagmar colpisce per forza e verità, facendo calare il lettore, anche quello che, in buona fede, ha creduto nella “bontà” di quel regime, in una realtà inimmaginabile di orrori e di imbarbarimento. La lettura del testo può essere intrapresa a vari livelli, sia come condanna definitiva e senza appello del regime, sia come testimonianza di un’esperienza di disumanizzazione integrale dell’essere umano incarcerato, sia come grande prova di fede e di dignità personale, senza santificazione, neppure postuma. Il libro, pubblicato in patria solo dopo la caduta del regime nel 1989 e oggi raccomandato agli studenti dal Ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca come lettura nell’insegnamento della storia del Ventesimo secolo, vede la luce in edizione italiana soltanto oggi, in un momento in cui, da parte di molti storici o intellettuali anche sinceramente lontani dall’ideologia comunista, si assiste non di rado (soprattutto in Italia e perfino, come nota Vitale, in ambienti cattolici) a una sorta di “revisione” o di una ancora frequente parziale “assoluzione” di quei regimi, unita a volte a una condanna bonaria, oppure a una rivisitazione piuttosto parziale o lacunosa degli stessi, facendo prevalere su tutto un presunto fine di perseguimento di una fantomatica “giustizia sociale”, della quale da questa testimonianza terribile non risulta proprio più nulla. Questo fenomeno, del resto, è visibile anche nella stessa Repubblica Ceca, seppure non corrisponda all’ufficialità: ogni libro, film o rappresentazione teatrale legata all’esperienza del tragico periodo comunista riscuote sempre grande successo e attenzione, anche se in pubblico molti preferiscono non esprimersi, sospendendo il giudizio. Dagmar trascorse quattordici anni in carcere. Venne liberata nel 1966 e, dopo aver visto il fallimento della “Primavera di Praga”, lasciò il suo Paese per emigrare in Australia, dove mise al servizio di altri carcerati e di tanti bisognosi la sua terribile esperienza, lavorando anche per Amnesty International. Morì a Perth nel 1995.
Stefano Citterio