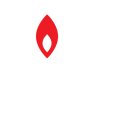Voci dalla guerra: Oleksij Symonov, organizzatore di eventi: “Gli amici mi chiamano il Mosè di Mariupol’”.
Nell’ambito del progetto “Voci dalla guerra”, portato avanti dalla rete di Memorial col Gruppo di difesa dei diritti umani di Charkiv (KhPG o “Memorial Ucraina”), pubblichiamo la testimonianza di Oleksij Symonov, carismatico organizzatore di eventi di Mariupol’, che ha guidato la fuga dalla città di un gruppo di 117 persone. L’intervista, realizzata da Denys Volocha, è disponibile nel canale YouTube di Memorial Italia coi sottotitoli in italiano.
Le traduzioni italiane sono a cura di Luisa Doplicher, Sara Polidoro, Claudia Zonghetti.
Denys Volocha
31.07.2022

Il carismatico 44enne Oleksij Symonov lavora nell’organizzazione di iniziative e gare sportive. Ritiene che la comunicazione svolga un ruolo fondamentale: più di una volta lo ha aiutato non solo a sopravvivere in una Mariupol’ occupata, ma anche a mettere in salvo chi divideva con lui il rifugio.
— Ci racconti com’è stato per lei il primo giorno di guerra a Mariupol’.
— Era stata una giornata concitata. Ai primi bombardamenti mia moglie era andata in panico: dovevamo partire. Non credevamo che sarebbe successo. Come si può pensare che nel XXI secolo qualcuno si metta a bombardare dei quartieri residenziali? Era inimmaginabile. Pensavamo a qualche missile in tutto, e che poi sarebbero andati via per risolvere la questione al tavolo delle trattative. Eravamo semplicemente sbigottiti: questo è stato il primo giorno.
— Quand’è che avete capito che non sarebbe finita lì e che bisognava partire?
— Direi intorno al 26-27 febbraio, quando ormai andarsene era diventato impossibile. Non avevo l’auto, ma anche se l’avessi avuta, non so se mi sarei arrischiato. Sulla strada per Mariupol’ c’era già una colonna di carrarmati russi, e chi è partito il 27 e 28 ha rischiato davvero grosso.
— In quale parte della città viveva? Com’è andata, lì da voi?
— Ero nel quartiere Neptun, distretto di Kal’mius’ke. Gli abitanti di Mariupol’ sanno dove si trova: è vicino alla fabbrica Illič. I primi giorni sono stati tutto sommato tranquilli rispetto al periodo successivo, perché poi a marzo sono arrivati i missili. Fino a quel momento avevamo sentito gli spari a Sartana e quelli nel microquartiere 23.
Erano molto forti ed eravamo spaventatissimi, ma se ci ripenso non era stato niente di che. Invece, quando i missili sono arrivati anche da noi abbiamo capito che facevano sul serio.
— Ci racconti come si viveva a Mariupol’ durante la guerra.
— Beh, all’inizio eravamo spaventatissimi. Appena iniziavano i colpi correvamo in rifugi improvvisati, dato che il comune non aveva provveduto a farne. Successivamente sono spariti luce, acqua e gas. Devo dire che ci hanno aiutato molto i film apocalittici di questi ultimi anni, così come le prove di evacuazione e i corsi di sopravvivenza che ci facevano fare a scuola. Andavamo a fare la legna e a prendere l’acqua, scioglievamo la neve. Raccoglievamo l’acqua piovana, facevamo provviste. Era importantissimo mantenere un buon livello di comunicazione: era molto più importante dei soldi, che ormai non avevano più valore. Nel nostro rifugio eravamo più di 280. Ci aiutavamo a vicenda, ed è stato così che siamo riusciti a sopravvivere. Chi è ancora lì cerca di sopravvivere allo stesso modo. Li portano via col contagocce, ma ci sono ancora tra 140 e 150 mila persone in quella situazione.
— Ha collaborato in qualche modo con l’esercito?
— Nel nostro quartiere c’era un ospedale militare. Quando avevo tempo, la prima settimana sono andato a dare una mano per mettere i sacchi davanti alle finestre ed evitare che andassero in frantumi. Così i medici potevano lavorare tranquilli. Salvavano non solo i militari, ma anche i civili feriti. Ho visto portarne alcuni quando sulla Kirova era caduto il primo missile, o forse era una bomba. Mentre noi riempivamo, legavamo e fissavamo i sacchi alle finestre, arrivò un signore anziano: “Scusate, mi sa che ho qualcosa nel fianco”. I medici lo visitavano e gli trovavano una scheggia. Due settimane fa ho visto un video in cui, accanto alla finestra dell’ospedale militare che io stesso avevo riempito di sacchi, dei giornalisti russi dicevano che quello era il quartier generale del Battaglione Azov: “Abbiamo tirato fuori i soldati che ci sparavano da lì dentro”. E ho pensato: “Ma guarda un po’… Se fossi rimasto, magari li avrei visti anche io, i soldati…”. C’era solo un piccolo dettaglio: non stavano sparando, salvavano vite. Prima che, come dicono loro, “lo liberassero”, il 15 o il 18 [marzo] l’ospedale era stato completamente sfollato. Per quanto ne so io, nel rifugio sul territorio della fabbrica, perché ora vedo chi sono i militari e i medici a cui danno la caccia. E mi affligge sapere che ci sia un mandato di cattura nei confronti di chi invece aiutava gli altri. Loro hanno salvato tante persone, ma chi penserà a salvare loro?

Sono andato al comando di polizia del distretto Kal’mius’kyi. Aiutavamo a cercare le persone, per quanto possibile. Più che cercare le persone, diciamo che portavano via i cadaveri. I militari ci rifornivano di medicine, quando ne avevamo davvero bisogno. Ci davano quello che potevano darci. Quando guardo il telegiornale e sento dire che bisogna lanciare le molotov contro i carri armati e cose di questo genere… Noi non abbiamo mai visto né carri armati, né soldati russi o della Repubblica Popolare di Doneck. Ci hanno spianato a colpi di mortaio, artiglieria e bombe aeree. I soldati li abbiamo visti solo quando abbiamo lasciato la città. Il nostro quartiere è stato praticamente distrutto, raso al suolo a colpi di artiglieria. Avevamo cinque voragini attorno al nostro rifugio, quando sono cadute le bombe aeree. Perché cinque e non sei? La sesta è finita su una centralina elettrica: l’ha rasa al suolo, ma senza cratere. Una centralina alta più di 4 metri completamente rasa al suolo. Sarà stato tra il 13 e il 16 marzo, ma il giorno preciso è irrilevante. L’unica cosa che contava era sopravvivere. Oggi sei sopravvissuto? Bene, vediamo domani. Ci organizzavamo per dare ai bambini dei pasti caldi e per prendere l’acqua, e stavamo attenti che non ci fossero strani marchi sui rifugi, perché gli sciacalli non ci fregassero la benzina dalle macchine. Tra il 13 e il 16 è stato pesantissimo: per ci hanno tartassato per tre giorni, proprio il nostro rifugio, forse ci avevano trovato con la geolocalizzazione. Venivano tutti a ricaricare i telefoni, lì da noi, e siamo diventati un bersaglio.
— Cosa ne è della sua abitazione e di quelle vicine?
— Non saprei, è difficile ottenere informazioni, perché in città nessuno ha il segnale. Come ha detto Kuleba [Ministro degli Esteri ucraino, N.d.T.]: “È finita: Mariupol’ non esiste più, è stata rasa al suolo”. Eppure ci sono ancora oltre 100 mila persone, si rende conto? Vivono lì, quindi Mariupol’ non è distrutta. La stanno distruggendo, piuttosto! Quindi bisogna mettere in salvo chi è rimasto. Freghiamocene delle case, pensiamo alle persone. Persone vive, che non riescono ad andarsene. Non glielo permettono, gli riempiono la testa di notizie false. Una cosa molto, ma MOLTO presente, ora…
– Ecco, esattamente: cosa le impediva di lasciare Mariupol’?
— L’assenza di informazioni, l’assenza di corridoi umanitari. Il fatto che non avessi un’auto, e che avessi tre figli cui non potevo far rischiare la vita. Abbiamo aspettato che facesse un po’ più caldo per non avere troppo freddo di notte, in viaggio. Abbiamo aspettato anche che la linea del fronte si allontanasse dal nostro rifugio, così quando saremmo partiti non ci avrebbero tartassati di colpi, come succede ovunque nei dintorni.
“Ho dei conoscenti che sono saliti su un autobus: ‘Vi portiamo a Zaporižžja’, gli hanno detto, e invece sono finiti vicino a Donec’k.”
— Secondo molte fonti, i russi starebbero portando in massa gli abitanti di Mariupol’ in Russia o nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. Lo hanno proposto anche a lei? Qualcuno che conosce ha accettato proposte simili?
— Sì, che ce l’hanno proposto. Ce l’hanno “venduta” così: “Potete andare a Rostov o a Donec’k, questo è l’autobus”. Ce lo dicevano già a Nikol’s’ke, o a Manguš. “Vi aspettano, vi daranno da mangiare e anche un lavoro: andrà tutto bene”. Degli “allegri facilitatori politici”, chiamiamoli così. Psicologi coi fiocchi, le dirò. Quando eravamo a Nikol’s’ke, era pieno di quei “libera[t]tori”: “Vi aiutiamo noi,” dicevano, “vi daremo da mangiare”. Avevamo un gran voglia di dirgli che noi da mangiare ce l’avevamo, e che avevamo una casa, che non avevamo bisogno di andare da nessuna parte perché potevamo andare dove ci pareva, prima. A Manguš ho capito che erano in cerca di personale: lo selezionavano e lo istruivano per mandarlo lì nella Repubblica Popolare di Donec’k o in Russia. Quando una mattina è entrato un militare, mi ha detto: “Allora, per quanto altro tempo intendete rimanere in questo asilo?”, e noi gli abbiamo risposto: “Siamo venuti per una notte, poi ce ne andremo altrove in Ucraina, vogliamo arrivare almeno a Zaporižžja”, a lui è scappato un “Ah, ecco…” e noi abbiamo subito capito cosa stesse tramando e che gli avevamo rovinato i piani. Non si aspettava una risposta del genere. Gli avevano detto di reclutare chi restava due, tre, quattro notti: quelli cedevano meglio.

Il 22 siamo arrivati a Manguš. Avevano requisito gli autobus di un convoglio umanitario che da Zaporižžja andava a Mariupol’. La sera arrivano e ci chiedono: “Chi vuole andare a Donec’k? Si può ancora partire”. Esco a guardare e penso: “È notte, cosa ci fanno qui questi autobus, che sta succedendo?”. Guardo meglio e vedo che sono dell’azienda di trasporti del comune di Zaporižžja. Chiamo i volontari di là e mi dicono che era arrivato un convoglio umanitario e che si erano fregati gli autobus. “Finiranno a Donec’k”, gli ho detto.
Quando sono tornato, ho sentito che davano la possibilità di scegliere se partire o meno. So bene com’è finita. Delle persone che conosco sono state attirate sull’autobus dicendo che sarebbero andati a Zaporrižžja, invece li hanno portati a Donec’k.
— Lei è una persona sempre molto allegra. Leggo sul suo Telegram che organizza iniziative molto seguite. Ci racconti cosa faceva prima che iniziasse l’invasione e che cosa pensa di fare ora.
— Prima dell’invasione la mia vita era bellissima. Per quest’anno avevo molti progetti. Io organizzo feste, ma faccio anche lo speaker durante manifestazioni sportive nazionali e internazionali. A Mariupol’ l’ho fatto per le partite di hockey, le arrampicate sportive, il canottaggio e la boxe, e in futuro lo avrei fatto anche per il basket. Sono anche speaker internazionale e ideatore di giochi, mi occupo di formare animatori e presentatori, organizzo feste e lavoro con i ragazzi. Ho lavorato e continuo a lavorare con la Fondazione “Ali gialloazzurre”, una fondazione ucraina a livello internazionale. Abbiamo già aiutato molti sfollati e continueremo a collaborare in questa direzione. Sono stato in contatto, per via del lavoro che svolgo da oltre 30 anni, con alcuni colleghi presentatori di Černivci che mi aspettavano da molti anni. Ed eccomi qui. Ora stiamo lavorando a un software di grafica per canzoni per bambini disabili. Scriviamo anche contenuti per gli animatori che lavorano sul territorio. E ci aiutiamo a vicenda, con gli altri amici volontari. La comunicazione è la chiave, è la comunicazione che salva le persone. Lo vede, no?, come si aiutano gli ucraini. Io ora vivo a Užhorod, dove mi hanno accolto persone che non conoscevo, ma che sono amici di amici. Ed è bellissimo che ci siano persone così.

— Stava parlando di come avete lasciato la città. Ci può raccontare com’è andata?
— Il 20 ci siamo accorti che c’era più silenzio del solito. Era anche più caldo. Il 21 sono uscito con un altro ragazzo del rifugio per controllare il quartiere: lui è andato da una parte e io dall’altra. E infatti abbiamo visto che sparavano un po’ più lontano da noi. Allora abbiamo radunato tutti quelli che volevano andarsene e ho annunciato che potevano prepararsi e prendere lo stretto necessario, che la mattina seguente saremmo partiti alle 8 in punto. A piedi. Ciascuno prendeva ciò che riusciva a portare da solo e via, veloci, perché dovevamo arrivare almeno a Nikol’s’ke o Manguš. Dove ci aspettavamo di trovare degli autobus, perché una del governo – il cui cognome inizia per ‘V’ e finisce con ‘ereščuk’ [Iryna Vereščuk, vicepremier ucraina, Ministra per la Reintegrazione dei Territori Temporaneamente Occupati – N.d.T.] – aveva annunciato che dal 15 ci sarebbero stati degli autobus tutti i giorni, sulla tratta Manguš-Berdjans’k. Una volta arrivati a Manguš, ho chiesto in giro e la risposta è stata: “Guarda che dal 24 febbraio non ne è partito uno, di autobus, su quella linea”. Alla fine i 15 chilometri da Manguš a Kamyševaty li abbiamo fatti a piedi, e siamo arrivati 10 minuti prima che chiudesse l’alimentari. Era una bottega di paese, di legno. Dovevamo comprare l’acqua e il pane: non pensavamo certo di dover camminare così tanto. Poi sono riuscito a contattare il sindaco del paese. “Non ho niente da offrirvi”, mi fa, “solo il circolo, ma non è riscaldato”. “L’importante è che ci sia un tetto sopra la testa” gli rispondo io. E in quel momento la signora del negozio esce e ci chiede da dove veniamo. Gli dico: “Da Mariupol’”. E lei: “Ma lasciate perdere il circolo! 12 possono venire da me. Ljuda, tu ne prendi 5, va bene?”. Insomma, ci hanno ospitato le famiglie a Kamyševaty, ci hanno fatto stare al caldo. Per la prima volta dopo un mese ci siamo fatti la doccia. A Kamyševaty ora ho la mia seconda famiglia. La mattina dopo ci hanno aiutato a proseguire il viaggio portandoci in macchina a Dem’yanivka e poi oltre. Abbiamo attraversato strade dissestate e sentieri partigiani per arrivare a Zaporrižžja, abbiamo passato 17-18 posti di blocco russi e della Repubblica Popolare di Doneck, fino ad arrivare in Ucraina. A Zaporrižžja ci hanno alloggiato in una scuola dell’infanzia e la mattina dopo siamo saliti a bordo di un treno, in un vagone tutto per noi.
“In 15 posti di blocco abbiamo visto tutta la Russia: c’erano udmurti, kazaki e ceceni. Tutta la Russia possibile e immaginabile, da Sachalin alla Jacuzia”.
Siamo partiti in 117 e siamo arrivati in 70. Alcuni sono andati a Rostov, in Russia, dove avevano parenti o amici. Certo, ciascuno ha diritto di scegliere. La differenza tra ucraini e invasori è proprio questa: noi abbiamo la possibilità di scegliere cosa fare e come farlo, e restiamo umani in qualsiasi circostanza.
— Può descrivere com’è un viaggio di questo tipo, con 117 persone? Io qualche escursione in montagna l’ho fatta, ma eravamo 20 al massimo. 117 persone che percorrono a piedi una distanza del genere…
— Si cammina in colonna, zaini in spalla, di buon passo. Chi ha lo zaino, chi una borsa, chi un trasportino con i gatti, o i bambini piccoli con zaino e borsa pure loro. È come una grossa processione. I miei amici che erano venuti a sapere che ero vivo mi scrivevano: “Tu non fai Symonov di cognome, ma ‘Symosè’. Salvi la gente attraverso deserti di asfalto”. Quando cammini e non senti le bombe, come quando abbiamo lasciato Manguš, va tutto bene, ma lasciare una città con il sottofondo dei colpi d’artiglieria è davvero terrificante. Quando dici che sparano lontano e si può rallentare il passo, tutti fanno “No, no, no!”, sia i grandi che i piccoli. C’erano persone di 70 anni e bambini di 5.
— I militari cosa facevano e cosa vi dicevano ai posti di blocco?
— A marzo evidentemente erano ancora angeli vestiti di bianco, i nostri “liberatori”. Che ci liberavano dalle nostre case, dalla nostra vita. Per non provocarci, dicevano: “Andate, andate! da quella parte!”. Figuratevi se non la conosciamo, la città! So che poi hanno cambiato atteggiamento, che aggredivano la popolazione, ma a noi hanno voluto dare l’impressione di essere brave persone. “Vi aiutiamo con questo e pure con quest’altro”. E noi, annuendo: “Sì, sì”. Non avevamo tempo per fermarci a parlare, e perché? Cosa potevano dirci che non sapessimo già? Niente. Cosa potevano farci? Beh, quello che potevano fare lo hanno fatto. Ci hanno lasciato senza radici e senza vita. Dovremo ricominciare da zero, ed è davvero dura.
Nell’attraversare i posti di blocco, si capiva quali erano russi e quali della Repubblica popolare di Donec’k. Innanzitutto, nei 15 posti di blocco russi che abbiamo passato c’era tutta la Russia. C’erano udmurti, kazaki e ceceni. Tutta la Russia possibile e immaginabile, da Sachalin alla Jacuzia. C’era uno jacuto che faceva il simpaticone. E uno della regione di Smolensk, direi. Tutti facevano quello che erano chiamati a fare. Prendevano gli uomini, cercavano i tatuaggi o le informazioni sul telefono, o i calli sulle dita – segno che avevano sparato. Però almeno era chiaro che si trattava di militari che avevano giurato fedeltà al proprio Stato. Gli ultimi 2 o 3 posti di blocco invece della Repubblica popolare di Donec’k, e quelli erano veramente degli str***… Mi scusi. Feccia armata, con la rabbia negli occhi. In uno ci è mancato poco che un soldato mi sparasse per un callo che avevo. “Hai sparato!”, e io: “Ma no, ho spaccato la legna!”, e mi ha puntato il fucile automatico in testa, caricandolo. Sono molto grato ai ragazzi che mi hanno portato via. Dove potevamo, gli abbiamo dato delle sigarette o qualcos’altro, per distrarli. Occhi bassi e solo “Sì, sì”, “No, no”: nient’altro, quando passi. Altrimenti ti becchi sfuriate, ti aggrediscono. Ed è molto pericoloso per te e per gli altri.

Bisogna sempre ascoltare la guida! E se ti dice “Non apriamo bocca”, vuol dire che la devi tenere chiusa. Le guide rischiano grosso. Molti dei volontari che sono stati fatti prigionieri e rilasciati dopo una o due settimane non sono stati puniti per il bene che hanno fatto, ma per colpa di qualcuno che stavano accompagnando e che o ha cercato la lite o ha fatto qualche battuta di troppo. I soldati non sono tutti uguali. Alcuni non avevano ricevuto istruzioni ed erano andati a Melitopol’, invece che a Mariupol’. Quindi i nostri sono stati in grado di organizzarsi e di dispiegare i militari a difesa della città. Quando il 27, o il 28 ho visto i carri armati russi che entravano a Melitopol’, ho pensato: “A cosa gli serve Melitopol’?”. E da Melitopol’ gli amici mi scrivevano: “Sono entrati, hanno attraversato la città e sono usciti”. E io: “Ah… quindi sono come Gazmanov [cantante filoputiniano – N.d.T.] che confonde Mariupol’ e Melitopol’”. Negli anni 2000, infatti, era venuto da noi per la Festa della Città e aveva detto: “Salve, Melitopol’!”.
— Quanto ai posti di blocco, ha mai visto che uccidessero dei civili, li portassero via o li torturassero?
— Sì! Quando siamo ripartiti, hanno preso un uomo dalla nostra colonna. Gli avevano trovato sul telefono dei messaggi con i militari e l’hanno preso. Non so che fine abbia fatto.
— Conosce persone che sono morte a Mariupol’? Uccise dai bombardamenti o dai cecchini, o da attacchi diretti dei militari?
— Ogni giorno ti arrivano informazioni, e ogni giorno col cuore spezzato leggi cognomi di persone che conosci. È davvero dura quando perdi qualcuno. Sono fortunato che i miei cari siano vivi. Il padre dei parenti di persone che stavano con noi è morto nel cortile di casa sua: un missile, e addio. Un uomo che fino a quel momento attraversava mezza città a piedi per andare a trovare le figlie. Loro gli dicevano “Resta con noi nel rifugio”, e lui: “No, ho la mia casetta, torno lì”. È molto dura.
— Si sarebbe potuto fare qualcosa per evitare, anche solo in parte, quello che è successo a Mariupol’?
— Certo. Sicuramente sì.
— E cosa?
— Almeno non riempirsi la bocca di “Ce la faremo, nessuno ci torcerà un capello”. Almeno prepararsi! Al posto di vantarsi e di farsi belli ci si poteva semplicemente preparare. Come si sono preparate le fabbriche. Le fabbriche che facevano scorte di cibi e predisponevano i rifugi, perché sapevano che se anche la guerra non scoppiava, era meglio farsi trovare pronti. E nei rifugi preparavamo razioni di cibo e taniche di acqua. C’è gente che ancora le usa e si salva, con quelle scorte. Immaginatevi se non ci fossero stati neanche quei rifugi. Pensate se, il giorno in cui è iniziato tutto, al posto del rifugio la gente avesse trovato una cantina chiusa o allagata. Senza sapere chi avesse la chiave. Invece no: “Qui c’è un rifugio, venite”. Sa, noi di Mariupol’ ci facciamo sempre riconoscere nelle altre città. Quando parte la sirena, noi non muoviamo un muscolo. Sa perché? Perché da noi le sirene non c’erano.
— Che cosa prova nei riguardi dei russi?
— Niente. Assolutamente niente. Però attenzione: i russi e i militari dell’esercito russo non sono la stessa cosa. I russi e il governo russo non sono la stessa cosa. Non serve sputare odio, l’odio non serve a nulla. A certa gente hanno fatto il lavaggio del cervello: “Ammazzateli tutti”, urlano. È difficile chiamarli russi, ma è difficile persino chiamarli esseri umani. Chi istiga a uccidere bambini o non so chi altro, non è un essere umano. A prescindere da dove viene. Se dalla Russia, o dal Bangladesh. O dalla Somalia. No? I russi, ora, non hanno scelta. Molti di loro non hanno sviluppato un pensiero critico. Molti di loro neanche capiscono cosa sta accadendo. Chi viene a fare la guerra e imbraccia le armi deve essere eliminato. È così. Ma chi vive nel suo piccolo mondo, è sempre un essere umano, lo è ovunque. Non ho più niente a che spartire coi russi. Purtroppo. È una generazione perduta, un paese perduto dove non voglio capitare. Sicuramente ci vivono anche persone normali che cercano di parlare – alcune hanno paura, altre no. Ma sono poche. È molto più semplice accendere la TV e bersi quello che ti dicono.