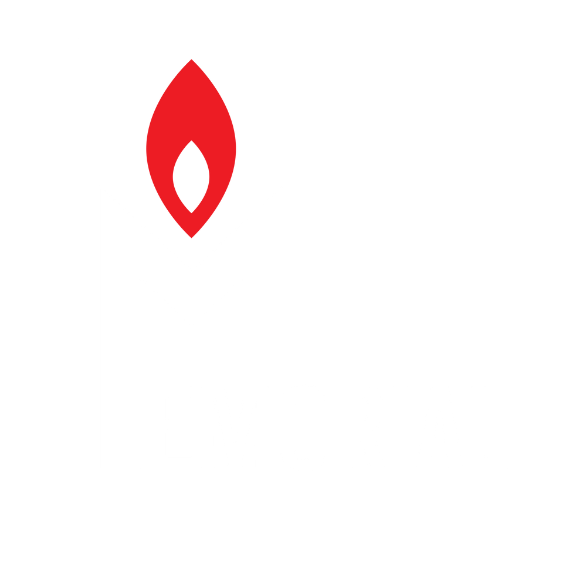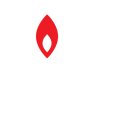Voci dalla guerra. Vitalij Bandruškiv, abitante di Mariupol’: “Niente patti, coi russi, e nessuna fiducia”.
Vitalij Bandruškiv ha lasciato con la famiglia Mariupol’ assediata dall’esercito russo. Alle sue spalle è rimasta una città distrutta, in cui sono stati presi di mira i civili. Anche se si aspettava la guerra, Vitalij non immaginava che essa avrebbe assunto tali proporzioni. Dopo avere raccontato la sua vicenda a Leonid Gol’berh, Vitalij Bandruškiv si è arruolato nelle Forze Armate ucraine. L’intervista è stata realizzata per il progetto “Voci dalla guerra”, portato avanti dalla rete di Memorial col Gruppo di difesa dei diritti umani di Charkiv (KhPG o “Memorial Ucraina”).
Il video dell’intervista in lingua originale coi sottotitoli in italiano è disponibile nel canale YouTube di Memorial Italia. Riportiamo qui la trascrizione del testo.
Le traduzioni italiane sono a cura di Luisa Doplicher, Sara Polidoro, Claudia Zonghetti.
Leonid Gol’berh
03.07.2023
Vitalij Bandruškiv abitava a Mariupol’, città tristemente famosa, e con la moglie e il figlio si è dovuto rifugiare a Drohobyč. Mentre preparavamo l’intervista per la pubblicazione si è presentato al reclutamento ed è andato a combattere gli invasori.
— Vitalij, ci racconti: di che cosa si occupava in tempo di pace?
— Sono ingegnere civile, ma ho quasi sempre insegnato nell’Università tecnica statale “Pryazovs’kyj”.
— Quando è arrivata la guerra nella sua vita?
— Nel 2014 la mia città è stata invasa dai soldati della sedicente DNR [Repubblica popolare del Donbas], a comando russo. Finché Mariupol’ non è stata liberata, la situazione era molto tesa: in quella fase della guerra cercavano di conquistare la città e c’era il rischio che la circondassero. A settembre del 2014 io, mia moglie e mio figlio (ancora piccolo) non ce l’abbiamo più fatta e siamo andati via. Siamo tornati l’anno dopo. Sapevamo di essere vicini alla linea del fronte, ma la città era comunque nella parte di territorio controllato dall’Ucraina.
Abbiamo cercato di ucrainizzare Mariupol’ in vari modi; aiutavamo i militari e facevamo volontariato.
— Era preparato al 24 febbraio?
— I militari e gli analisti ci avevano avvertito che una cosa del genere sarebbe successa: lo sapevamo e dentro di noi eravamo preparati. Fisicamente e materialmente, invece, era quasi impossibile prepararsi.
A dicembre-gennaio si era ormai lì lì, la situazione poteva precipitare da un momento all’altro. Alla fine il 24 [febbraio] è andata secondo lo scenario più probabile: bombardamenti, caccia che sorvolavano tutto il territorio e così via…
Speravamo che i russi avrebbero capito che avevamo chi ci aiutava e avremmo opposto resistenza.
La mattina del 24 febbraio abbiamo sentito che tutta l’Ucraina era sotto i bombardamenti, e poi che stavano bombardando anche noi a Mariupol’. Sapevamo che la città era fortificata, soprattutto dalla parte verso la Russia e l’aeroporto, ma ci aspettavamo che sarebbe stata dura e che ci sarebbe servito un aiuto esterno. Non ci aspettavamo che ci avrebbero accerchiati. Pur sapendo che ci sarebbe stata la guerra, non ci eravamo preparati a sfollare, anche perché io e mia moglie abbiamo entrambi genitori anziani.
— Come ha trascorso gli ultimi giorni prima di lasciare la città?
— Il primo giorno sono comunque andato a lavorare: mezza giornata; il secondo abbiamo cercato di fare la spesa, e già era difficile trovare provviste: tutti facevano scorte, e si è poi visto che era stata una buona idea.
Con il tempo ho capito che al lavoro non c’era niente da fare e che stare a casa mi pesava. Sono andato al centro di volontariato più vicino, dove conoscevo qualcuno, e ho dato una mano a caricare pacchi. Si facevano anche dei turni di guardia durante la notte. Aiutavamo i militari e la polizia, che iniziavano ad avere problemi di rifornimento, col cibo caldo in particolare. Ma la polizia e i pompieri non stavano fermi un attimo. Facevano il loro lavoro, e noi li aiutavamo come potevamo.
Tre o quattro giorni dopo sono iniziati i problemi con l’elettricità, ma poi sono riusciti a risolverli e ad allacciare la corrente. L’assistenza tecnica municipale funzionava ancora bene.
Qualche tempo dopo, però, la corrente è andata via, di conseguenza siamo rimasti senz’acqua e abbiamo iniziato a cercare dove procurarcela. Diversamente da altre città, noi non abbiamo fontanelle. Il comune ha provveduto a mandare le autobotti, ma c’erano file lunghissime. Allora la gente si è ricordata di pozzi e sorgenti. L’acqua è la prima necessità, è chiaro.
Dopo qualche giorno è andato via il gas. Non dappertutto: all’inizio solo nei quartieri dove le condutture dell’acqua erano state bombardate. E la gente ha iniziato a soffrire il freddo. Per fortuna il nostro quartiere è stato uno degli ultimi. Quanto alla nostra famiglia, abitavamo insieme a mia sorella e alla sua (e insieme siamo poi partiti), ma avevamo ingressi diversi. Siccome faceva freddo, a un certo punto ci siamo riuniti tutti in una stanza per stare più caldi. Abbiamo resistito per tre o quattro giorni, poi la temperatura è scesa e ci siamo trasferiti dai miei genitori, che abitano in periferia. Loro avevano la stufa, e all’epoca la legna si trovava ancora.
Sparito il gas, tutti gli abitanti hanno preso sega e accetta e hanno segato e spaccato tronchi per cucinare e riscaldarsi. Il peggio è toccato a chi abitava nelle palazzine più alte, perché la legna si cercava in cortile, e scendevano tutti. Quando andavi a trovare gli amici li trovavi con il cappotto e il cappello, perché in casa la temperatura era vicino allo zero. Era strano, per Mariupol’: per una settimana di notte siamo scesi a -6 o -10, addirittura…
Quando è andata via la corrente sono cominciati i problemi di comunicazione, perché i telefoni si scaricavano. Per chi aveva un gruppo elettrogeno era tutto più facile. Gli altri dovevano cercare il posto o gli amici da cui farlo. Io andavo al centro di volontariato.
Dopodiché ha iniziato ad andare via il segnale. All’inizio pensavamo che fossero i ripetitori a non funzionare, ma poi i militari ci hanno detto che attorno a Mariupol’ avevano piazzato dei disturbatori di segnale e che per questo c’era poco campo. Quando si trovava un punto in cui il segnale appariva, subito scattava il passaparola per andare a leggere le notizie e sentire che cosa succedeva, perché i siti di informazioni cominciavano a essere bloccati. Adesso, si sa, li hanno bloccati tutti e si può accedere solo ai media russi.
In quel periodo abbiamo anche smesso di ricevere le stazioni radio ucraine, sono rimaste solo quelle della DNR.
— Come è riuscito a lasciare la città?
— Siamo andati via tutti insieme con la mia auto: quattro adulti e tre bambini. In undici ore di viaggio siamo arrivati da Mariupol’ a Zaporižžja. Non è stato semplice: non avevo previsto di fare quel viaggio d’inverno, l’auto era in garage con gli pneumatici estivi e senza scorte di carburante. Eppure, nonostante le temperature sottozero, la neve che aveva cominciato a fioccare e gli pneumatici estivi, siamo arrivati a Zaporižžja. La benzina è bastata per miracolo: negli ultimi metri la lancetta era già sul rosso.
A Zaporižžja ci hanno accolto e dato da mangiare al supermercato “Epicentr”.
Mio cognato ci aspettava a Dnipro da due settimane. Siamo rimasti quasi una settimana per vagliare le possibilità migliori di trovare lavoro e alloggio. Qualunque angolo dell’Ucraina andava bene, se era un po’ più sicuro.
Grazie ad altri conoscenti abbiamo trovato una sistemazione temporanea a Sambir e a Drohobyč. Poi abbiamo affittato un alloggio qui da voi. Adesso siamo di nuovo insieme, tutti e sette.
— In che condizioni era Mariupol’, quando l’ha lasciata?
— Quando siamo partiti, ci siamo salvati per miracolo dai bombardamenti, ma ci siamo salvati, noi e anche l’auto. Abbiamo solo visto i missili cadere attorno a noi. Abbiamo anche visto molti feriti, e gente che viaggiava su auto malridotte. E abbiamo imparato a distinguere i rumori: ormai capivamo quando un missile ci passava vicino.
Che cosa abbiamo visto? Le case distrutte del centro città. Abitavamo proprio lì, noi. I miei genitori, invece, stavano nel paese di Piščane, oltre il porto.
A quel punto la città veniva bombardata ogni giorno, e abbiamo visto i crateri.
La prima settimana, per esempio, quando non c’era segnale, sono andato io dai miei a Piščane per vedere se li avevano colpiti. Ma la situazione era abbastanza tranquilla. Tre giorni dopo, mentre portavo da loro la nonna di mia moglie, già c’erano segni di bombardamenti. Di fatto hanno preso di mira un paese dove non c’era nessun obiettivo militare.
Prima che partissimo è successa una cosa analoga: non hanno bombardato il porto, ma un paese famoso per il suo festival. I r-ascisti hanno colpito la centrale elettrica con un bombardamento dal mare.
Il 15 marzo ho fatto scorta di legna e acqua per la casa dei miei, dove ormai abitavamo in undici. L’indomani, alla vigilia della partenza, abbiamo visto colonne di mezzi che se ne andavano. Non era un convoglio umanitario organizzato, ma un’iniziativa autonoma di singoli individui. I posti di blocco sono arrivati dopo.
Siamo passati per la via dei Metallurgici, che attraversa la città. E ho visto che tutti gli edifici della mia università avevano i segni dell’artiglieria. Attraversare il centro era difficilissimo: io mi spostavo in bicicletta ma c’erano pezzi di vetro ovunque, le finestre erano sfondate, le case distrutte, del tutto o per metà. Insomma, nel centro di Mariupol’ c’erano solo macerie. Dove prima c’era un sottopassaggio pedonale ho visto un cratere largo dieci metri e profondo quattro-cinque.
Era il 10 [marzo, N.d.R.]. Poi mi hanno detto che l’aviazione nemica aveva iniziato a “occuparsi” del centro città.
Un giorno sono andato al centro di volontariato per sentire le ultime notizie, e ci ho trovato la polizia che diceva che chi partiva lo faceva a suo rischio e pericolo. Dunque ho provato a informarmi su un itinerario possibile. In quel momento è arrivato un ragazzo: veniva dal teatro, lo avevano appena centrato…
È stato a quel punto che, rischio o no, abbiamo deciso di provare ad andarcene anche se bisognava attraversare i territori occupati.
Benché ci fosse poco segnale, abbiamo ricevuto il messaggio che diceva di un “corridoio verde” per veicoli privati lungo il tal percorso.
Chiaramente prima di partire ho visto le macerie. Tempo dopo ho saputo che già all’epoca il 70% delle abitazioni era stato distrutto…
— Ha ancora parenti a Mariupol’?
— Ci sono mio padre e mia madre, e mia sorella con loro, perché l’anno scorso hanno avuto problemi di salute. C’è anche la nonna di mia moglie. Mio suocero viveva a Talakivka, ma abbiamo perso i contatti il 26 febbraio, e da allora non ne sappiamo più nulla…
— Perché gli occupanti hanno trattato Mariupol’ in questo modo?
— Evidentemente non sono riusciti a prendere la nostra città in tempi rapidi, come prevedevano, grazie alla difesa dei nostri soldati. Gli occupanti sono arrivati solo alla periferia e sono stati respinti.
Per questo hanno sparato sui civili: per creare il panico, per far scappare la gente e far pressione sui militari, che tra i civili hanno parenti. Militari e civili ricevevano sms da numeri di telefono russi con la richiesta di arrendersi.
I r-ascisti dicevano di bombardare la base dell’“Azov”, ma in realtà i primi obiettivi “militari” che hanno preso di mira sono stati una scuola e una palazzina di nove piani vicino alle basi della Difesa Territoriale.
Non so se l’hanno fatto apposta o per sbaglio, sta di fatto che il 90% delle scuole in città è distrutto, e anche tutte e sette le università di Mariupol’.
— Ha senso condurre trattative e stringere accordi di pace con i russi?
— Conosco un po’ la storia, e dal 2014 mi sono messo a studiarla più a fondo. Quindi so che con certa gente non si possono fare accordi. Le trattative in corso sono solo strategia, una parvenza di diplomazia; non ci si può fare alcun affidamento.
Traduzione: Associazione internazionale per la difesa dei diritti umani (sezione tedesca)